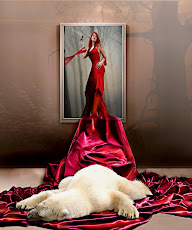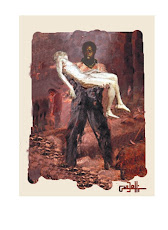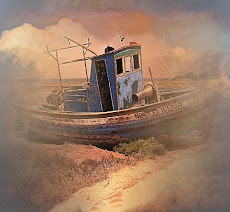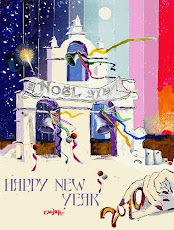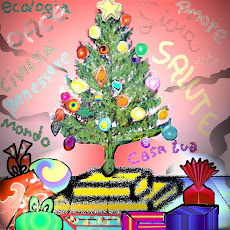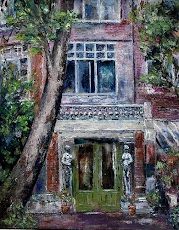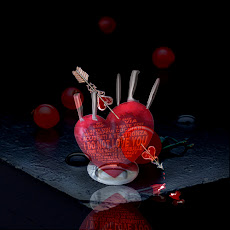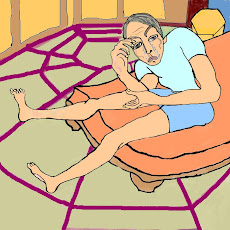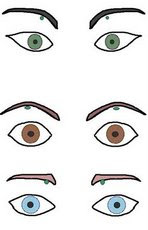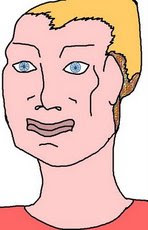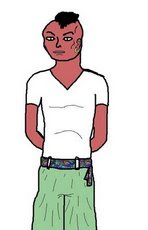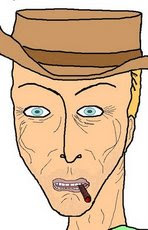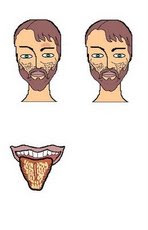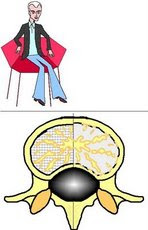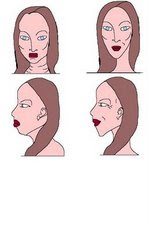mercoledì 23 dicembre 2015
AUGURI
IL blog resta in pausa per le feste
...a dopo la befana!!!
Un milione di auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici e lettori e anche a chi passa di qui per caso: dato che niente succede per caso.
Vi auguro serenità e gioia e per il mondo che possa arrivare almeno un po' di pace!!!
...a dopo la befana!!!
Un milione di auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici e lettori e anche a chi passa di qui per caso: dato che niente succede per caso.
Vi auguro serenità e gioia e per il mondo che possa arrivare almeno un po' di pace!!!
venerdì 18 dicembre 2015
LEDUM PALUSTRE
In questa stagione fredda e umida, ecco un rimedio omeopatico dal profilo molto interessante: Leduc palustre
E’ il rosmarino selvatico della famiglia delle Ericacee.
Tropismo per articolazioni, muscoli, tessuti connettivi, pelle.
MORFOLOGIA
I tipi Ledum sono robusti, pletorici, con diatesi emorragica; il loro viso è congesto, oppure, benché più raramente, sono pallidi e delicati, con scarso calore vitale, ma temono il calore esterno. Hanno facilmente sabbia rossa nelle urine.
PSICHISMO
Come carattere sono soggetti collerici, che possono avere crisi violente di rabbia, amanti della solitudine, misantropi.
SINOMI E INDICAZIONI
(1) reumatismi articolari acuti e cronici;reumatismi muscolari,artrite, lombalgia; gotta.
E' un ottimo rimedio delle artriti e artrosi infiammate, della gotta, delle piccole articolazioni tumefatte, dolenti, infiammate: alluce, dita, caviglie. Rigidità, anchilosi. Dolore acuto. Il soggetto presenta fasi di agitazione e fasi di prostrazione; è freddoloso e rabbrividisce, ma il calore aggrava i suoi dolori, mentre l'acqua gelida e il freddo li migliorano. Il dolore e le infiammazioni partono dalla periferia (ad esempio dal piede) e salgono verso il corpo.
(2)Punture di insetti.Punture dolorose da cui non esce sangue o esce in quantità minima rispetto all'importanza della sintomatologia dolorosa. LEDUM ha per le ferite da punta la stessa importanza di Arnica per le contusioni, tanto più se sono presenti:
freddezza ed edema della parte lesa;
pallore locale;
paralisi o sensazione di paralisi;
cianosi successiva della parte;
punture di insetti o animali il cui veleno provoca infezione delle vie linfatiche o del sangue. Punture di zanzare, di api, di vespe, punture di ragni, morsi di topo, cane, serpente, soprattutto quando non sopravviene nessuna emorragia esterna e vi è un gonfiore edematoso, molle e freddo a livello della parte offesa.
Si può usare Ledum anche come preventivo delle punture di insetti.
Gli apicoltori corrono molto meno rischi di essere punti se prendono tre globuli di Ledum 9 CH prima di occuparsi dei loro alverari.
Alcuni soggetti dicono di attirare o chiamare a sé le zanzare. Ledum palustre 5 CH, cinque granuli mattino e sera durante tutta la stagione degli insetti o le vacanze, eviterà di essere un cibo prelibato.
Per calmare il dolore si può praticare l’applicazione locale di un tampone imbibito della seguente preparazione:
Calendula T.M.
Ledum palustre T.M. } 30 ml.
Apis T.M.
questo mix apporta un sollievo quasi immediato.
(3) Traumi.
Traumi dell'articolazione tibio tarsica (caviglia). Il rimedio rivela un'azione elettiva sulla caviglia ed è importante per tutti i tipi di trauma in questa sede. E’ importante per l'edema, la tendenza emorragica ed i conseguenti ematomi, tanto più se vi sono le modalità generali del rimedio: miglioramento con le applicazioni fredde ed aggravamento con il calore e con il movimento.
In un trauma si pensa subito ad Arnica, ma, quando la traccia della botta tarda a sparire, una dose di Ledum 9 CH risolve il problema, perché Ledum completa l’azione iniziata da Arnica.
Indicato in particolare anche per i traumi da strumenti appuntiti come chiodi, coltelli ecc ecc. Strumenti appuntiti sono pure le siringhe e Ledum si può usare per eliminare l’ematoma risultante dalla mancanza di abilità di un infermiere nel praticare un’iniezione o un prelievo.
(4) Alterazioni oculari.
E' il rimedio delle ecchimosi, soprattutto periorbitali come "l'occhio nero" che tarda a sparire.
(5) Azione preventiva sul tetano
Deve a questo scopo essere assunto tempestivamente, avendo massima efficacia sulla lesione finché localizzata, prima che il processo si espanda ed il dolore si irradi verso la radice dell'arto Hypericum).
(6)Acne rosacea degli etilisti: cinque granuli alla 5 CH, due volte al giorno, unitamente al rimedio di fondo (Sulfur, Lachesis, Nux vomica, Thuya, ecc.).
MODALITA’
Peggiora = Con il calore del letto. Di notte. Con il movimento. Assunzione di uova, vino ed alcolici in generale.
Migliora= Il soggetto è molto freddoloso, tuttavia i disturbi migliorano con il freddo, specie con docce o bagni freddi, bagnando i piedi in acqua fredda.
Migliora anche con il riposo.
Secondo il prontuario Heel, invece, migliora sia con acqua con acqua fredda che calda.
POSOLOGIA
In tutti i casi verrà usato alla 5 CH, somministrato ogni ora, in associazione con gli altri rimedi indicati;
oppure, secondo i casi, 2-3 granuli ogni 2 ore
INCOMPATIBILITA’
Ledum palustre è incompatibile con China.
ANTIDOTO
Nella sfera cutanea Ledum è un antidoto di Rhus toxicodendron; a sua volta è antidotato da Camphora.
giovedì 10 dicembre 2015
La magia dei fermenti
Microrganismi effettivi
EM
Voglio segnalarvi questi prodotti, facilmente acquistabili in rete, oppure contattando la pagina del centro culturale Ting presente su Facebook per mezzo della quale sarete messi in contatto con il nostro produttore di fiducia.
Ma allora questo articolo è una pubblicità?
No: è qualcosa di più. È il racconto della mia esperienza.
Io li sto usando da circa un mese per le pulizie domestiche e ne sono entusiasta.
Si tratta di fermenti che puliscono facendo risparmiare tempo e fatica, bonificano l'ambiente e ci permettono di bypassare i detersivi abituali così nocivi per l'ambiente e spesso per le mani.
Ecco quindi alcune pagine da visitare per sapere in dettaglio di che si tratta:
http://emecorevolution.blogspot.it/
http://www.greenme.it/consumare/eco-spesa/11529-microrganismi-effettivi-usi-em
http://www.bionrg.it/microorganismi-effettivi-P14.html
http://fervida.jimdo.com/preparazione/
Infine da questi punti di partenza potete trovare i molti altri collegamenti se volete provare a produrre i fermenti
domenica 6 dicembre 2015
Ibisco
l’ibisco è quella bellissima pianta dai grandi fiori rossi, almeno questa è la varietà più conosciuta ma ne esistono tipi con fiori di altri colori, che sicuramente tutti avete visto molte volte. Si tratta di un genere diffuso soprattutto ai tropici e se ne contano circa 200 specie, quasi tutte coltivate come piante ornamentali da giardino. Una graziosa tradizione in vigore nelle isole polinesiane è quella secondo cui le ragazze tengono un fiore di ibisco sull’orecchio destro per indicare un fidanzamento, sul sinistro per indicare che sono single e disponibili a una nuova frequentazione. Nel linguaggio amoroso dei fiori, poi, donare un ibisco significa dire all’amata “tu sei bella”.
Hibiscus sabdariffa è l’unico considerato officinale; in Egitto, India, Antille e Africa lo si usa come bevanda: il famoso e squisito karcadè.
Appartiene alla famiglia delle malvacee. La droga è costituita dai calici fiorali, ad alto contenuto di acidi organici (ibiscico, citrico, malico, ossalico), che gli conferiscono un gradevole sapore acidulo. Fino alla pubblicazione di uno studio finalizzato alla valutazione dell’efficacia antipertensiva del karcadè, erano note soltanto le proprietà diuretiche, rinfrescanti, lenitive e leggermente lassative. La commissione E tedesca ( in pratica la farmacopea europea) inserisce l’hibiscus nella lista negativa delle droghe, quelle cioè carenti di documentazione scientifica che ne attesti l’efficacia. Da notare comunque che non esistono obiezioni al suo impiego come correttore del sapore in tisane. Già nel luglio del 2005, sulla rivista Phytomedicine, è stato pubblicato un interessante studio, controllato e randomizzato, che paragonava dal punto di vista dell’efficacia e sicurezza, l’infuso al 10% di hibiscus sabdariffa una volta al giorno a 25 mg di captopril due volte al giorno. La ricerca, durata 4 settimane, ha coinvolto circa 100 pazienti in età compresa tra i 30 e gli 80 anni. I risultati non hanno evidenziato differenze statisticamente significative tra i due trattamenti né come efficacia terapeutica né come tollerabilità e sicurezza. Un’ipotesi che apre la strada alla possibilità di somministrare agli ipertesi una tazza di profumato karcadè in luogo di ace-inibitori e similari.
Secondo il mio abituale costume, quando un rimedio risulta adatto ai miei sintomi, ho quindi voluto provare di personaggi effetti della tisana: nel mio caso la pressione sistoli a è diminuita di ben venti punti, mentre la diastolica in modo variabile e di dieci punti.
L'effetto è, invece, migliorato aggiungendo il succo di bacche di gogji due volte al giorno.
Ovviamente, il fatto che i valori pressori sono variabili, sia da un soggetto all'altro sia nello stesso soggetto, porta a dover stabilire una dose e un tempo di somministrazione da decidere in base alla situazione e sotto il controllo del medico o dell'operatore sanitario (farmacista, naturopata ecc) che vi segue.
venerdì 27 novembre 2015
CEFALEA
In diverse occasioni ho parlato dettagliatamente dei vari rimedi da scegliere
(v. indice del blog); aggiungo ora altre brevi note.
con questo termine si intende mal di testa in generale.
L'emicrania è un tipo di cefalea ma questa distinzione per il momento resta solo come una classificazione da studio, in quanto in olistica il mal di testa viene esaminato in modo personalizzato.
Un rimedio omeopatico su cui voglio richiamare la vostra attenzione è Coffea a bassa diluizione più volte al giorno da assumere ai primi sintomi.
ALIMENTAZIONE
Lo scatenamento del dolore dopo l’assunzione di cibi ricchi di tiramina come ad esempio formaggi, vini, cioccolata (antidoto è la rosa canina) ecc, è spiegato con l’innesco di un fattore trigger, ma non necessariamente di tipo allergico. Comunque i cibi citati e il glutammato (esempio dado per brodo) sono vietati. Altri diffusi trigger sono: latte, frumento,uova, arance, pomodori, segale, riso, pesce, avena, zucchero, lievito, uva, cipolle, soia, carne di maiale e di manzo , arachidi, noci, caffè, nocciole, mais, aspartame.
Ma gli alimenti che possono provocare emicrania sono numerosi perciò bisogna provare di volta in volta con l’esclusione. Una eccessiva dose di vitamine+minerali assunti come integratori può scatenare emicrania. Tra gli anti-nutrienti abbiamo anche: nitrati presenti nei salumi e nella carne in scatola, noccioline tostate, agrumi vecchi, aringhe e alimenti affumicati in generale, pesce salato, fegato di pollo, fave, crauti, vaniglia, salsa di soia e bevande alcoliche.
Alimenti consigliati sono PESCE GRASSO, AGLIO e tutti i cibi con caratteristiche antiaggreganti; nutrienti utili sono il MAGNESIO, ACIDI GRASSI OMEGA3. SUCCHI DI CAVOLO A FOGLIA LISCIA, AGLIO, PREZZEMOLO come fonti di Mg; ZENZERO,MELONE,AGLIO per l’effetto antiaggregante.
CROMO come integratore. Sebbene si sia constatato che le cefalee sono associate a stati di ipoglicemia, non c’è modo di sapere se i sintomi attuali riflettano questa o un’altra funzione del cromo: fatto sta che il quadro sintomatologico migliora con la somministrazione di cromo. Per riattivare il metabolismo energetico dei mitocondri viene prescritta la RIBOFLAVINA , o vitaminaB2, a dosaggio elevato; essa serve per la profilassi, riduce l frequenza degli attacchi e la loro durata. Come la riboflavina, anche il COENZIMA Q10 migliora il metabolismo energetico ed è efficace nella profilassi dell’emicrania• Nell’acqua potabile la quantità massima di Pb è fissata a 50 mcg/L; un’intossicazione da Pb può causare, tra i tanti sintomi, una cefalea cronica.
VITAMINA B2 o riboflavina : in uno studio alla dose di 400 mg per 3 mesi ha comportato un dimezzamento degli attacchi. Può sembrare un risultato modesto dato anche lo scarso numero di soggetti dell’esperimento, ma data la sua innocuità e il basso costo, i ricercatori consigliano di aggiungerla alla dieta come integratore.
domenica 22 novembre 2015
Epifisi e melatonina
L’epifisi, detta anche ghiandola pineale, regola la maturazione degli organi sessuali e presiede all’alternanza ciclica dei foto-periodi (cioè periodi di luce) preposti al controllo di molte funzioni organiche. L’attività di controllo sull’assetto endocrino si esercita lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi ed è di tipo essenzialmente frenante. Il ruolo endocrino dell’epifisi raggiunge il massimo funzionale nel 7° anno di vita e cessa con la pubertà.
Dopo la scoperta della melatonina fu chiaro che l’epifisi non è una struttura di tipo vestigiale
(come dire un organo accessorio che per l’uomo di oggi è obsoleto, come ad esempio i peli del corpo: accade spesso che la medicina ufficiale quando non conosce il ruolo o il funzionamento di un organo o di un tessuto, lo definisca vestigiale: come a dire quasi del tutto inutile!!!)
ma un importante componente del sistema PNEI (psico-neuro-endocrino-immunitario): sistema che potremmo definire “il 3° occhio”. Ancora presente in alcuni rettili sauri, è di fatto un occhio accessorio, deputato alla ricezione della luce.
Numerosi fattori stressanti possono influire negativamente sull’attività epifisi-melatoninica con varie ripercussioni sul comportamento vegetativo, somatico e sociale.
Negli uccelli la pineale funziona da bussola. E’ un magneto-recettore in grado di orientare il corpo nello spazio. Anche nell’uomo i campi elettromagnetici modificano l’attività della ghiandola pineale e riducono la secrezione di melatonina (esempio la jet-lag syndrome).
Nei mammiferi è un vero e proprio orologio per tutte le stagioni.
Anche la pelle, oltre all’epifisi, è un lettore di luce solare; ad esempio possiamo ricordare la formazione di vitamina D3, le correlazioni tra albinismo e depressione ecc ecc.
Depressione in età adulta e rachitismo in età pediatrica potrebbero essere due lati della stessa medaglia. Più le cellule epidermiche sono vitali più sono foto-emettenti; più sono foto-emettenti, più sono in grado di assorbire UV solari con conseguente ottimale osteosintesi ed armonico sviluppo scheletrico. La depressione riduce la vitalità cellulare (si osserva con camera Kirlian) e quindi l’assorbimento di UV con conseguente sviluppo di quadri rachitici.
Anche nell’osteoporosi la relazione con la depressione è stata documentata.
La melatonina viene fisiologicamente secreta al buio dall’epifisi durante il sonno.
Recenti studi hanno dimostrato che la retina può secernere melatonina: anche l’occhio è una sede peculiare per il set e reset del ritmo circadiano. Pertanto, l’uso indiscriminato e prolungato di melatonina in dosi ponderali (cioè quelle che troviamo negli integratori fino a 1 mg e nei farmaci 2 mg) può danneggiare la vista: alti livelli di melatonina retinici associati ad esposizione di luce intensa possono potenzialmente compromettere la retina.
sabato 14 novembre 2015
Respirazione
RESPIRAZIONE
Ecco alcune note sulla fisiologia della respirazione, per introdurre l'argomento della respirazione consapevole e altre pratiche respiratorie descritte in campo olistico.
Un atto respiratorio si svolge in 4 fasi:
—inspirazione
—pausa (apnea)
—espirazione
—pausa.
Ad ogni inspirazione l’aria entra dalle narici.
Dato che nell’aria possono essere presenti odori o altre sostanze direttamente o non direttamente manifeste alla nostro ordinario stato di coscienza, voglio sottolineare che esse vengono percepite in quanto i lobi olfattivi sono direttamente prospicienti alla radice del naso. La presenza di questi odori o sostanze quindi viene trasmessa dal bulbo olfattivo al sistema limbico e al sistema nervoso vegetativo. Quindi possiamo considerare il fatto che l’aria inspirata compie un percorso doppio. Una piccola parte si dirige direttamente al bulbo olfattivo e il resto si dirige attraverso la laringe alla trachea e quindi ai bronchi per andare infine a collabire, adeguatamente umidificata e riscaldata, la superficie interna dei polmoni.
Diaframma
È formato da tre elementi
-- il setto traverso o centro frenico
-- la membrana pleuro--peritoneale
-- il meso-esofago da cui originano i pilastri del diaframma.
La parte periferica del diaframma è costituita dalla giustapposizione di sottili muscoli digastrici i cui tendini mediali si intrecciano a formare il centro frenico. La parte muscolare si divide a sua volta in una porzione vertebrale, una costale e una sternale.
Inoltre dobbiamo prestare particolare attenzione alle intersezioni
aponeurotiche dei muscoli, in quanto il sistema fibroso aponeurotico crea una continuità tra muscolo e muscolo, contribuendo così alla formazione di catene muscolari che rendono inoperante ogni correzione che sia riferita a un singolo muscolo o segmento.
Sistema sospensore del diaframma
l’aponeurosi cervicale profonda, o fascia prevertebrale, si continua a livello toracico con l’ispessimento posteriore della fascia endocardica.
la guaina viscerale diviene la guaina dell’esofago, o fascia periesofagea, che prosegue fino al diaframma raccogliendo lateralmente i legamenti del polmone. le guaine dei grossi vasi sono rinforzate dalle espansioni del pericardio. il foglietto profondo dell’aponeurosi media e un’espansione della guaina viscerale formano insieme l’aponeurosi cervico-pericardica. Il foglietto superficiale si continua con il legamento sterno-pericardico superiore.
Attraverso questa serie di fasce e legamenti, il diaframma è come sospeso alla base del cranio, alla colonna cervico-dorsale fino a T4 e alla parte alta del torace. (al di sotto di T4 la fascia non aderisce ma resta sospesa)
in questa zona cervico-toracica troviamo una catena fasciale molto solida che chiameremo tendine del diaframma. la catena fibrosa continua senza interrompersi al di sotto del diaframma i cui pilastri sono fissati alla colonna lombare tramite una robusta porzione fibrosa. Le loro inserzioni sulle vertebre lombari, insieme a quelle del muscolo psoas, all’aponeurosi posteriore del trasverso, della fascia trasversalis e dei suoi rinforzi posteriori (legamenti lombo-costali di Henlé) offrono un solido punto di attacco alla fascia iliaca che scende fino all’arto inferiore. A questo livello non troviamo più una catena fasciale anteriore, come al di sopra del diaframma, ma due catene laterali, destra e sinistra, che scendono da entrambi i lati fino al bacino e agli arti inferiori.
Vediamo ora come si svolge la funzione respiratoria
in generale tutte le funzioni necessarie alla sopravvivenza (respirazione, circolazione, digestione e metabolismo ecc) sono garantite e gestite dal sistema nervoso vegetativo. Il diaframma rappresenta un’eccezione a questa regola, potendo essere attivato sia volontariamente che automaticamente. Ogni volta che il suo funzionamento dipende dal controllo automatico, il diaframma svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza, sul piano circolatorio e digestivo, attraverso un’azione di pompa nel corso della quale il centro frenico resta mobile. Per assicurarsi funzioni meno indispensabili alla vita come la fonazione o la statica (sollevare pesi), il comando volontario può comportare una momentanea fissazione del diaframma e del suo centro frenico. Questa azione deve necessariamente essere limitata nel tempo poiché durante tale periodo, la funzione respiratoria, che è essenziale, non è più assicurata. Ecco quindi un esempio di come in alcuni casi si ha una superiorità (del tutto transitoria) che il sistema nervoso cosciente può esercitare su quello autonomo.
Il diaframma è dunque un muscolo molto importante per quanto riguarda il controllo nervoso, ed è l’esempio per eccellenza della relatività delle funzioni: concetto così scomodo e difficile da accettare per l’epistemologia occidentale non olistica. Ad esempio basti pensare a come blocchiamo il nostro respiro quando siamo sotto stress.
Il blocco diaframmatico, in virtù della catena fasciale appena descritta, può avere come conseguenza un blocco in flessione della zona occipitale e quindi ecco come una difficoltà respiratoria e persino una sinusite può avere cause distali oltre che locali (prime vie aeree).
Ecco alcune note sulla fisiologia della respirazione, per introdurre l'argomento della respirazione consapevole e altre pratiche respiratorie descritte in campo olistico.
Un atto respiratorio si svolge in 4 fasi:
—inspirazione
—pausa (apnea)
—espirazione
—pausa.
Ad ogni inspirazione l’aria entra dalle narici.
Dato che nell’aria possono essere presenti odori o altre sostanze direttamente o non direttamente manifeste alla nostro ordinario stato di coscienza, voglio sottolineare che esse vengono percepite in quanto i lobi olfattivi sono direttamente prospicienti alla radice del naso. La presenza di questi odori o sostanze quindi viene trasmessa dal bulbo olfattivo al sistema limbico e al sistema nervoso vegetativo. Quindi possiamo considerare il fatto che l’aria inspirata compie un percorso doppio. Una piccola parte si dirige direttamente al bulbo olfattivo e il resto si dirige attraverso la laringe alla trachea e quindi ai bronchi per andare infine a collabire, adeguatamente umidificata e riscaldata, la superficie interna dei polmoni.
Diaframma
È formato da tre elementi
-- il setto traverso o centro frenico
-- la membrana pleuro--peritoneale
-- il meso-esofago da cui originano i pilastri del diaframma.
La parte periferica del diaframma è costituita dalla giustapposizione di sottili muscoli digastrici i cui tendini mediali si intrecciano a formare il centro frenico. La parte muscolare si divide a sua volta in una porzione vertebrale, una costale e una sternale.
Inoltre dobbiamo prestare particolare attenzione alle intersezioni
aponeurotiche dei muscoli, in quanto il sistema fibroso aponeurotico crea una continuità tra muscolo e muscolo, contribuendo così alla formazione di catene muscolari che rendono inoperante ogni correzione che sia riferita a un singolo muscolo o segmento.
Sistema sospensore del diaframma
l’aponeurosi cervicale profonda, o fascia prevertebrale, si continua a livello toracico con l’ispessimento posteriore della fascia endocardica.
la guaina viscerale diviene la guaina dell’esofago, o fascia periesofagea, che prosegue fino al diaframma raccogliendo lateralmente i legamenti del polmone. le guaine dei grossi vasi sono rinforzate dalle espansioni del pericardio. il foglietto profondo dell’aponeurosi media e un’espansione della guaina viscerale formano insieme l’aponeurosi cervico-pericardica. Il foglietto superficiale si continua con il legamento sterno-pericardico superiore.
Attraverso questa serie di fasce e legamenti, il diaframma è come sospeso alla base del cranio, alla colonna cervico-dorsale fino a T4 e alla parte alta del torace. (al di sotto di T4 la fascia non aderisce ma resta sospesa)
in questa zona cervico-toracica troviamo una catena fasciale molto solida che chiameremo tendine del diaframma. la catena fibrosa continua senza interrompersi al di sotto del diaframma i cui pilastri sono fissati alla colonna lombare tramite una robusta porzione fibrosa. Le loro inserzioni sulle vertebre lombari, insieme a quelle del muscolo psoas, all’aponeurosi posteriore del trasverso, della fascia trasversalis e dei suoi rinforzi posteriori (legamenti lombo-costali di Henlé) offrono un solido punto di attacco alla fascia iliaca che scende fino all’arto inferiore. A questo livello non troviamo più una catena fasciale anteriore, come al di sopra del diaframma, ma due catene laterali, destra e sinistra, che scendono da entrambi i lati fino al bacino e agli arti inferiori.
Vediamo ora come si svolge la funzione respiratoria
in generale tutte le funzioni necessarie alla sopravvivenza (respirazione, circolazione, digestione e metabolismo ecc) sono garantite e gestite dal sistema nervoso vegetativo. Il diaframma rappresenta un’eccezione a questa regola, potendo essere attivato sia volontariamente che automaticamente. Ogni volta che il suo funzionamento dipende dal controllo automatico, il diaframma svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza, sul piano circolatorio e digestivo, attraverso un’azione di pompa nel corso della quale il centro frenico resta mobile. Per assicurarsi funzioni meno indispensabili alla vita come la fonazione o la statica (sollevare pesi), il comando volontario può comportare una momentanea fissazione del diaframma e del suo centro frenico. Questa azione deve necessariamente essere limitata nel tempo poiché durante tale periodo, la funzione respiratoria, che è essenziale, non è più assicurata. Ecco quindi un esempio di come in alcuni casi si ha una superiorità (del tutto transitoria) che il sistema nervoso cosciente può esercitare su quello autonomo.
Il diaframma è dunque un muscolo molto importante per quanto riguarda il controllo nervoso, ed è l’esempio per eccellenza della relatività delle funzioni: concetto così scomodo e difficile da accettare per l’epistemologia occidentale non olistica. Ad esempio basti pensare a come blocchiamo il nostro respiro quando siamo sotto stress.
Il blocco diaframmatico, in virtù della catena fasciale appena descritta, può avere come conseguenza un blocco in flessione della zona occipitale e quindi ecco come una difficoltà respiratoria e persino una sinusite può avere cause distali oltre che locali (prime vie aeree).
domenica 8 novembre 2015
Interazione individuo e ambiente
Questa settimana vi propongo un breve stralcio da questo articolo trovato qui:
OMEOPATIA E LINFOCITI
di A. Micozzi, S. Graziosi, R. Femia, G. Santini
di A. Micozzi, S. Graziosi, R. Femia, G. Santini
Dice Cushing: un medico è tenuto a prendere in considerazione non tanto un organo ammalato, e neppure l'intero individuo, bensì l'uomo nel mondo in cui vive. Sotto questo aspetto, il complesso delle interazioni, che l’individuo stabilisce con l’ambiente, nel corso della sua vita, è costituito dall’insieme delle risposte agli stimoli esterni. Tali stimoli possono essere di varia natura, in modo da indurre risposte sempre più complesse, che tendono a coinvolgere l’uomo nella sua globalità. Molto importante, al riguardo, sembra essere il periodo di latenza tra lo stimolo e la risposta. Il sistema endocrino, a parte alcune eccezioni, quali le funzioni del timo, tenderà a produrre una serie di risposte immediate, che dipendono, sostanzialmente, dalla breve emivita degli ormoni. Esempi evidenti sono dati dalla produzione di insulina alla introduzione del cibo nello stomaco o, ancor più, le reazioni surrenaliche di allarme agli eventi imprevisti. In alcuni casi, comunque, lo stimolo ambientale può interferire con l’intima struttura funzionale delle cellule, soprattutto a livello del nucleo. Da qui una serie di conseguenze imprevedibili, tali da condurre, con un periodo di latenza anche molto variabile, alla trasformazione cellulare in senso degenerativo o neoplastico. Quelle fisica (radiazioni ionizzanti) e chimica (sostanze inquinanti e tossiche di varia natura) rappresentano validi esempi di interazione critica, nelle quali l’individuo, in realtà, subisce in modo quasi ineluttabile gli stimoli esterni. In altri casi, le risposte tendono a essere memorizzate
o, addirittura, personalizzate, e costituiscono lo “spessore” psichico, ossia la somma delle esperienze accumulate nel corso della vita, tali da indirizzare o, in senso patologico, condizionare, le successive risposte e, quindi, il comportamento complessivo dell’individuo. La notevole complessità della strutturazione psicologica, però, mette in evidenza il rischio di indeterminatezza e di interpretazione dei fenomeni emotivo/comportamentali, i quali richiedono una profonda conoscenza della dimensione spazio/temporale sperimentata da una persona nel suo ambiente. Questo “limite ermeneutico” pone, oggettivamente, qualche difficoltà nella comprensione formale del comportamento, anche se lo studio della psiche condensa i molteplici meccanismi con i quali l’individuo sperimenta, in sé, la triade stimolo/risposta/memoria. Una condizione del tutto analoga, ma con delle ricadute pratiche di notevole rilevanza, è rappresentata dalla cosiddetta “interazione biologica”, ossia dall’insieme delle risposte linfocitarie agli stimoli infettivi. Dopo una fase storica, nella quale la medicina ha avuto modo di liberarsi completamente dalle congetture e dai dogmi dell’umoralismo, mediante l’avvento prorompente della microbiologia, ossia lo studio dell’ambiente biologico, si è avvertita la necessità, sempre più marcata, di comprendere le modalità con le quali l’individuo diventa malato, dapprima concedendo alla immunologia una limitativa nozione di difesa, ma in seguito considerandola all’origine degli stati patologici acuti e cronici. Seguendo l’antica “stoa” e la moderna immunopatologia, possiamo ben affermare che l’individuo risponde a uno stimolo esterno con il “pathos”, ossia con una condizione di sofferenza (da cui il termine “paziente”) ben più complessiva del concetto latino di “malattia”, per il quale il “malum” si impadronisce del “malato” a tal punto, da indurre gli umoralisti a evacuare una improbabile “materia peccans”. Lo stesso concetto di “immunitas”, legato alla iniziale evidenza di una protezione ai successivi stimoli infettivi di identica natura, limita fortemente a un solo aspetto, l’insieme dei meccanismi che inducono pathos, il quale si verifica proprio nel momento in cui si risponde. Un esempio di tale risposta è dato dall’allergia, nella quale uno stimolo specifico (l’allergene) è in grado di provocare una risposta immediata, nella maggior parte dei casi sistemica e altamente selettiva. In altri casi, tuttavia, le manifestazioni cliniche non hanno un rapporto causa/effetto così evidente, ma sono mediate proprio dal tempo. Sotto questo aspetto, è noto che il periodo di incubazione di una epatite A coincide con una serie di meccanismi graduali: legame del virus con i recettori (presenti sui macrofagi/monociti), viremia, processazione dell’antigene e sua presentazione sulla membrana degli epatociti, riconoscimento da parte dei linfociti citotossici, mediante recettori specifici, necrosi epatica conseguente, sintomatologia di stato. Questo esempio, estremamente semplificato, può contribuire a spiegare la nozione di “immunopatologia”, intesa come la conseguenza clinica (comprendente sintomi soggettivi e segni obiettivi) di una risposta specifica a uno stimolo altrettanto specifico. Nella sua interazione biologica con l’ambiente, pertanto, l’individuo si ammala solo quando è in grado di rispondere. Ciò permette di comprendere anche le nozioni di suscettibilità o resistenza agli agenti patogeni, le quali vanno intese nel senso, rispettivamente, della presenza o assenza di recettori e corecettori linfocitari, specifici per gli antigeni.
Per il momento mi fermo a lasciarvi riflettere su queste parole. Mi propongo di tornare sull’argomento per sviluppare altri filoni del ragionamento
NOTA
L'immagine è un'opera di Vincente Romero Redondo
sabato 31 ottobre 2015
MEDITAZIONE SULLE PAURE OPPRIMENTI
PREMESSA
molte persone soffrono di ansia da anticipazione. Questo tipo di ansia si manifesta sotto forma di idee drammatiche su qualcosa che potrebbe accadere al soggetto o ai suoi cari.
Questo tipo di paure le troviamo spesso in persone dotate di una fertile fantasia. Ecco che quando si trovano sotto stress, usano questa fantasia in modo autolesionista.
Ad esempio se hanno letto un romanzo o visto un film horror, ecco che tutti i fantasmi e i mostri si concretizzano nella loro immaginazione sotto forma di disastri di ogni tipo. Non perché credano che quegli eventi siano realmente possibili o probabili, bensì perché hanno bisogno di coltivare e nutrire le loro paure: può darsi che ciò accade percé vogliono nascondere a se stessi il vero nocciolo del loro malessere, perché sanno di non poter cambiare quella situazione-nocciolo; perché non vogliono o non possono (perché se lo facessero, troppe cose di contorno verrebbero scardinate e quindi il danno sarebbe maggiore del beneficio) cambiare quella situazione. Spesso non vogliono nemmeno permettersi il lusso di dire a se stessi questa verità per lo stesso motivo che ho indicato tra parentesi.
Dichiarare di aver paura della morte o della malattia è una affermazione molto comoda perché condivisa dal “buon senso comune”. Nessuno ti condannerà e neppure giudicherà se dirai di essere oppresso da pensieri angosciosi per motivi di salute. Al contrario, se quello che ti fa paura è la vita per alcuni aspetti ineludibili che ti presenta, potresti essere giudicato capriccioso, pieno di fisime o, peggio un uomo acido e cattivo, annoiato per troppo benessere: una sorta di Madame Bovary!!!
Che si tratti di vere paure per questioni che hanno una sia pur remota possibilità di avverarsi o di paure di facciata che coprono il vero problema, io propongo questa meditazione che ci aiuta a fare chiarezza, a fare anche un po’ di pulizia e magari a trovare dei bei momenti di totale vuoto mentale, liberandoci dai pensieri e dalle scene immaginarie che ci opprimono.
§§§
PREPARAZIONE
Durata circa 25 minuti.
Puntate una sveglia che vi segnala la prima metà dell’esercizio dopo dieci minuti e una che vi segnala la fine dopo altri dieci: il momento in cui dovrete eseguire il colpo di scena finale.
Sedetevi in una posizione comoda, in un luogo della vostra casa che vi piace particolarmente sul piano estetico. Ci sono certi angoli che ci piacciono particolarmente. Se non ne avete uno, createvelo questo primo passo è necessario.
Quindi il luogo che scelgo sarà un angolo dove ho una poltrona o un divano comodi, o il letto o uno spazio per posizionare una stuoia con qualche cuscino. Di fronte a me posso vedere la vetrata del balcone che dà su un bel panorama o sul giardino o magari sul mare! Oppure posso avere una parete dove c’è un quadro che mi piace particolarmente, e un mobiletto particolare oppure una grossa candela dalla forma scolpita… insomma avete capito cosa intendo.
Vi trovate quindi in una posizione comoda, con qualcosa di gradevole di fronte a voi ogni volta che deciderete di aprire gli occhi. Questa “location” costituisce il vostro radicamento durante l’esercizio. Infatti, se vedete che i pensieri negativi dovessero disturbarvi ugualmente mentre meditate, potrete aprire gli occhi e tornare in contatto con la vostra postazione di partenza.
Scegliete un’immagine che per voi rappresenta qualcosa di mostruoso, spaventoso e ripugnante.
Ora osservate bene nei dettagli questa immagine per qualche minuto.
ORA COSTRUITE IL VOSTRO FILM
stando ad occhi aperti, potete pure scrivere due righe per la trama dove indicate : il mostro, il luogo tetro e ripieno di elementi disturbanti, il luogo bellissimo e la scena finale del film come indico qui di seguito.
TRACCIA PER LA TRAMA
— Siete inseguiti dal mostro della figura. Voi camminate in un luogo prima familiare ma che presto si fa tetro mentre il mostro cammina dietro di voi a volte a qualche metro di distanza, a volte fino a un passo da voi.
Particolarmente interessante è l’effetto che si ottiene immaginando di camminare e anche di correre pur restando seduti in una posizione comoda. Proprio la stessa sensazione che si può avvertire in un sogno. Solo che questa volta il regista del vostro incubo siete voi stessi.
Inscenate la vostra sequenza pericolosa usando le vostre paure già conosciute. Ad esempio se soffrite di vertigini immaginate di fuggire scendendo una scala ripida e attraversando un ponte sospeso; se avete la fobia degli insetti, immaginate di fuggire muniti di un ventaglio che usate per spazzare nugoli di insetti volanti che ostacolano il vostro cammino. Insomma gli esempi su questa materia possono essere infiniti.
—Quando suona la prima sveglia immaginate di essere arrivati in un luogo bellissimo mentre continuate a camminare o in certi momenti a correre. Questo luogo può essere una spiaggia, un terreno incolto, un paesaggio tropicale, una pista vuota, insomma un luogo che dovete scegliere tra quelli che più di tutti vi danno, nella vita vera, una grande sensazione di benessere e gioia. Quindi ad esempio persino un luogo al coperto come l’interno di un edificio, un castello o altro.
Mentre continuate a fuggire non potete fare a meno di notare la bellezza di ciò che vi circonda (il mare, la spiaggia, il viale alberato, il vialetto del giardino, i corridoi luminosi dalle pareti damascate di un antico castello ecc ecc). A volte persino rallentate per osservare tutto ciò che di bello state attraversando, senza tralasciare di stare attenti a non farvi raggiungere dal mostro. Notate ora però qualcosa di cui non vi eravate accorti prima: il mostro sembra rallentare ogni volta che voi rallentate come se volesse solo inseguirvi ma non prendervi.
— Quando suona la seconda sveglia eccoci al COLPO DI SCENA FINALE in cui essendovi caricati dell’energia del luogo bellissimo che state attraversando decidete di girarvi ed affrontare il mostro faccia a faccia, di provare a fare una trattativa con il mostro.
Quindi vi girate e vedete che il mostro non è così ripugnante come era all’inizio. Si è trasformato in qualcosa di inoffensivo e persino carino, come un personaggio dei fumetti. Così gli parlate, gli dite che prima vi faceva paura ma che ora vi fa solo tenerezza. Lo salutate e aprite gli occhi. Fate qualche respiro profondo e quando vi sentite ben centrati sul presente potete alzarvi e svolgere le vostre normali attività.
CONSIDERAZIONI
La tecnica che propongo si basa su questi semplici elementi da usare per il nostro cortometraggio:
—un mostro scelto appositamente e osservato in una immagine. Questo rappresenta il NOCCIOLO DEL NOSTRO PROBLEMA
—una serie di elementi di disturbo che derivano dalle nostre fobie o semplici idiosincrasie già conosciute. Queste rappresentano GLI OSTACOLI nel nostro percorso.
— un luogo dove la scena cambia ed è quello per voi più gradevole (mare, montagna, giardino, frutteto, castello, pista di pattinaggio ecc ecc). Questo rappresenta che IL CAMBIAMENTO DEL VOSTRO STATO D’ANIMO RESTA POSSIBILE NONOSTANTE IL MOSTRO ANCORA VI INSEGUE
—COLPO DI SCENA FINALE serve a consolidarvi nell’idea che le paure ce le siamo create noi stessi e quindi, se vogliamo, possiamo decidere di cambiare il finale del nostro film.
Man mano che procedete con questa meditazione vi accorgerete che il vostro filmino cambierà in alcuni dettagli. Va benissimo: questo indica che state trovando nuovi modi di vedere la vostra situazione e presto non tarderà a presentarsi la soluzione definitiva, la liberazione definitiva da quel pensiero che vi opprime.
NOTA Le immagini sono due famose opere della grande pittrice surrealista Remedios Varo.
sabato 24 ottobre 2015
TOSSE parte quarta
INULA
si caratterizza per l’azione espettorante e antisettica (OE 1-3%) il che la rende utile nel trattamento sintomatico della tosse e nelle affezioni dell’apparato respiratorio.
Per essere più dettagliati diremo che ha azione espettorante diaforetica, antibatterica, spasmolitica, broncospasmolitica. Utilizzo specifico: il suo equilibrio di stimolazione e sedazione della mucosa del basso tratto respiratorio, combinato con la leggera azione amara (che migliora le secrezioni gastrointestinali e l’assorbimento di nutrienti) lo rendono uno specifico rimedio per l’asma bronchiale e la bronchite cronica.
Dose= 1,5-3 g al giorno in infuso, 6-15 ml di estratto idroalcolico (1:5) , oppure 12-30 gocce di TM.
Posologia della tintura madre: TM 30 gocce per 3 volte al dì. Si può usare alla dose di 1 cucchiaino da caffè per tazza d’acqua bollente per fare inalazioni.
Effetti collaterali da iperdosaggio sono: disturbi gastrointestinali, crampi, paresi (commissione E 1988).
ISSOPO
Ha proprietà espettoranti, antisettiche e stimolanti (OE) per cui viene usato nel trattamento delle forme catarrali dell’apparato respiratorio e nei raffreddori. Si usano i fiori. Oltre alle saponine contiene fellandrene, un OE che viene eliminato attraverso le vie aeree, favorendo la fluidificazione del muco e stimolando al tempo stesso la sua eliminazione. L’azione espettorante è favorita dalla presenza di saponine. E’ indicato non nella fase acuta ma nel periodo statico, quando i fenomeni congestizi e infiammatori sono attenuati. L’OE è neurotossico: è bene pertanto non usarlo come tale (allo stato puro). La pianta viene molto usata come infuso. TM 20 gocce per 3 volte al dì.
LAVANDA
Azione balsamica, antisettica e spasmolitica bronchiale.
LICHENE ISLANDICO
(Cetraria islandica L.) è conosciuto principalmente come bechico emolliente. Le mucillagini esplicano attività protettiva a livello di mucose infiammate o irritate; la presenza dell’acido usnico e degli acidi lichenici (principi amari) conferisce proprietà antibiotiche e batteriostatiche. Vi sarebbe inoltre un’azione immunostimolante. Risulta particolarmente utile nel trattamento della bronchite acuta. La presenza di principi amari ne sconsiglia l’uso in caso di ulcera duodenale e gastrite. Per la presenza sempre maggiore di piombo nella droga (30 mg/Kg di peso secco) il suo uso può risultare poco sicuro.
Tintura madre (TM) 25 gocce per 3 volte al dì.
Una formulazione classica per la tosse stizzosa è:
timo TM 25 ml
lichene islandico TM 15 ml
liquerizia TM 10 ml
20 gocce più volte al dì.
Particolarmente utile negli anziani per l’azione lenitiva e antibiotica, per combattere il catarro e calmare le tossi secche, il lichene islandico è molto diffuso nelle regioni artiche ma anche sulle Alpi italiane. Ha un piccolo tallo ramificato che costituisce la droga. I principali costituenti sono un principio amaro, l’acido cetrarico o cetrarina, sfruttato per l’azione amaro-tonica, e da un amido, la lichenina, con proprietà emollienti. Contiene fino al 65% di mucillagini alle quali sono dovute le proprietà lenitive sulle mucose irritate. Ha inoltre spiccate proprietà antimicrobiche, dovute alla presenza di acido usnico.
LIQUERIZIA
Contiene saponine triterpeniche. Il composto attivo è la glicirrizina, cui si deve l’azione emolliente ed espettorante, utile per lenire le infimmazioni dell’orofaringe e per favorire l’allontanamento del muco in eccesso dalle vie respiratorie.
MAGGIORANA
Azione antisettica ed espettorante; si usano le sommità fiorite di Origanum Majorana. TM 40 gocce 3 volte al dì.
MALVA
Appartiene alla stessa famiglia dell’altea ed ha proprietà ed indicazioni simili. Le sue mucillagini hanno azione idratante e riparatrice delle mucose e svolgono un’azione emolliente e antinfiammatoria del cavo orale e dell’apparato respiratorio. Ha anche un’azione espettorante in quanto aumenta la secrezione bronchiale e ne migliora la qualità.
MARRUBIO
Si usano le foglie e le sommità fiorite. Oltre alle saponine contiene un lattone diterpenico, la marrubina, che viene eliminato per via polmonare e agisce sulle mucose bronchiali provocando la secrezione di un muco più fluido. Grazie alla presenza di mucillagine impedisce al tempo stesso un’eccessiva disidratazione delle mucose ed ha inoltre un’azione disinfettante sulle mucose. Ha un profilo di sicurezza elevato per cui è indicato anche per anziani e bambini. Indicato come prima scelta per tracheite e tonsillite, bronchite cronica e acuta, tosse non produttiva, influenza, raffreddore e asma.
Dose: 1-3 g di infuso, oppure 4-10 ml di estratto idroalcolico (1:5) oppure 8-20 ml di TM.
MIRTO
Anch’esso è ricco di OE. L’azione è fluidificante , espettorante e blandamente spasmolitica. Nel formulario nazionale c’è la specie composta per tisana al timo; viene indicata una tisana bechica e fluidificante bronchiale così composta:
timo erba 25%
finocchio frutti contusi 15%
liquirizia radice 25%
plantago foglie 35%
1 cucchiaio per tazza d’acqua bollente. Somministrare 1-3 tazze al dì. Una buona preparazione è lo sciroppo espettorante-emolliente:
timo TM 15 g
liquirizia TM 5 g
altea TM 5 g
sciroppo semplice 75 g.
Somminitrare a cucchiai più volte al dì.
PINO
Azione balsamica e antisettica. Si usano preferibilmente le gemme raccolte alla fine dell’inverno perché più ricche di principi attivi rispetto agli aghi. Come per l’eucalipto, le gemme sono ricche di un OE balsamico e antisettico.
Infuso: 1 cucchiaio raso di gemme per tazza d’acqua bollente dopo 5 minuti filtrare e bere 3-4 tazze al dì.
PLANTAGO
Plantago lanceolata ha azione bechica, espettorante, antinfiammatoria (iridoidi). Viene usata per le patologie ORL e broncopolmonari in virtù dell’azione emolliente e sedativa svolta dalle mucillagini e per l’azione antivirale e astringente dei tannini. L’aucubina, che si trova soprattutto nella foglia, possiede anche un’azione antiallergica, per cui l’uso della pianta risulta utile nella bronchite cronica asmatiforme. TM: 30 gocce per 3 volte al dì.
POLIGALA
è una pianta contenente saponine. Originaria del Nord America, è una delle più usate come sciroppo, infuso, estratto fluido e polvere. Si usano le radici. Dosi elevate possono causare vomito e diarrea.
PRIMULA
presenta azione secretolitica, espettorante, antinfiammatoria per cui risulta particolarmente efficace nel trattamento sintomatico della tosse. E’ indicata nelle forme bronchiali, nella pertosse o nelle forme pertussoidi, nell’asma. Dosaggi elevati e prolungati possono provocare nausea e vomito. TM 30 gocce per 3 volte al dì.
Gocce espettoranti e spasmolitiche:
primula, plantago e timo ana parti
somministrare 20 gocce più volte al dì.
Una formulazione della commissione E:
liquirizia radice 25%,
primula radice 25%,
altea radice 25%
anice frutti contusi 25%;
fare infuso e bere 3 tazze al dì lontano pasti.
PROPOLI
azione balsamica e antisettica, dotata di azione antibatterica specialmente verso i gram+ che sono i più frequenti nelle infezioni delle prime vie respiratorie.
RIBES NIGRUM MG+ROSA CANINA MG
è particolarmente indicato per le proprietà antinfiammatorie svolte dai 2 rimedi. Ribes per l'effetto antiallergico e rosa canina per ricostruire le difese immunitarie.
ROSOLACCIO
papaver rhoeas, è conosciuto da sempre come calmante della tosse e blando sedativo. Viene usato come adiuvante nella pertosse e nelle forme pertussoidi, come bechico nella terapia delle bronchiti catarrali acute. I fiori contribuiscono a calmare lo spasmo, favoriscono l'espettorazione e determinano un'azione diaforetica utile nelle forme febbrili. Facilita il riposo notturno. Fa parte delle famose specie pettorali. TM 20 gocce per 3 volte al dì.
Il rosolaccio, comune papavero, ha proprietà sedative dovute alla presenza di piccole quantità di alcaloidi, di cui i principali sono readina e reagenina. Non si usa la capsula come nel papavero da oppio, ma i petali che contengono anche antocianosidi, sfruttati in passato per le proprietà coloranti. L’azione sedativa della tosse è legata principalmente all’inibizione del centro della tosse a livello centrale e, in misura minore, all’inibizione dei centri tussigeni a livello bronchiale.
TIMO
se ne distinguono 2 varietà: serpillum e volgare.
Viene usato per la sua azione antisettica, espettorante e fluidificante. Ha anche una buona azione bechica e spasmolitica; indicato per bronchiti acute e croniche, nella pertosse, nella tosse asmatica e nelle forme catarrali. Le preparazioni contenenti timo serpillo sono più blande grazie al minor contenuto in OE e sono meglio tollerate. Le indicazioni sono uguali. TM 40 gocce per 3 volte al dì. L’OE è ricco di fenoli. Viene caratterizzato in timolo (il timolo è 25 volte più potente del fenolo come disinfettante nei confronti di numerosi microrganismi). L’eliminazione di tali componenti avviene in gran parte a livello bronchiale. A proposito dell’effetto espettorante vale quanto detto per grindelia. L’azione spasmolitica bronchiale è eccellente per il timo, un po’ più scarsa per il timo serpillo. Il timo era usato dagli egizi come incenso. Nel medioevo era simbolo di coraggio. Per gli erboristi del ‘600 curava le cefalee e i disturbi nervosi. Per preparare una tisana antiasma e antitosse basta 1 cucchiaino di foglie lasciate in infusione per 5-7 minuti. Si beve calda anche 4 volte al dì. Una buona formulazione per la tosse è:
malva 30
edera terrestre 30
timo sommità 20
eucalipto foglie 20
Un cucchiaio raso per tazza d’acqua, infondere per 10 minuti, dolcificare con miele di tiglio o eucalipto e bere 2-4 tazze al dì.
VERBASCO
blando effetto sedativo (flavonoidi) utile per favorire la distensione e il sonno. Rientra nella tisana dei 4 fiori: malva, verbasco, rosolaccio e altea ana g. 10g in 150 ml, infondere per 15’ e bere 1 tazza al dì lontano pasti.
VIOLA MAMMOLA
Viola odorata. L’OE e le mucillagini ne caratterizzano l’attività. Lo sciroppo preparato a partire dai fiori viene usato nelle forme bronchiali acute e nei raffreddori. E’ un blando lassativo particolarmente indicato per anziani, pazienti debilitati e bambini. La TM 30 gocce per 3 volte al dì. Nel medicamenta sono descritti 2 modi di preparazione:
- petali di viola freschi p1, acqua bollente p2. Fare infusione per 12h, quindi colare con leggera pressione. Nel filtrato sciogliere il doppio del suo peso di zucchero. Filtrare poi per panno lo sciroppo ancora caldo
(2) violaTM g 5 sciroppo semplice qb a 125 ml. Posologia1-6 cucchiaini /die in base all’età.
SUCCHI FRESCHI
è utile il seguente schema:
—al mattino 1 cucchiaio di succo di equiseto in mezzo bicchiere d’acqua
— a mezzogiorno stessa dose 15' prima del pasto e alla sera stessa dose prima di coricarsi.
— A giorni alterni con una miscela di succo di farfara+ plantago.
Per le bronchiti con febbre e infezione respiratoria succo di timo+echinacea due volte al dì mattino e sera.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Informazioni personali

- Marina Salomone
- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone
per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com