Regolazione del tono vascolare a livello endoteliale
sabato 17 maggio 2014
IPERTENSIONE parte seconda
Regolazione del tono vascolare a livello endoteliale
L’endotelio è quella pellicola che fodera l’interno dei vasi e del cuore stesso dove prende il nome di endocardio. Si tratta di un tessuto molto attivo che tra le tante azioni di cui si incarica ha quella di intervenire sul tono vascolare.
Il tono vascolare basale è il grado di contrazione della parete muscolare dei vasi in condizioni basali cioè a riposo. Infatti, ovviamente, in condizioni di sforzo o di forti emozioni, le arterie possono allargare il loro diametro per permettere un maggiore afflusso di sangue negli organi dove necessita e ai muscoli. In pratica si ha una attivazione maggiore del sistema nervoso simpatico con produzione di adrenalina e NA e viene messo in moto tutto il sistema di emergenza dell’organismo per poter “fuggire o attaccare”. Durante uno sforzo, una corsa e ancor più una vera fuga, la pressione arteriosa aumenta parecchio e questo è un fatto fisiologico. Diventa patologico se aumenta quando non occorre e cioè in condizioni di riposo o durante un’attività sedentaria.
I vasi sono costituiti da tre strati concentrici: il più interno è appunto l’endotelio e nel cuore l’endocardio; lo strato intermedio, che è anche il più spesso, è il mesotelio e nel cuore il miocardio costituito da tessuto muscolare; il più esterno, che potremmo definire esotelio, è la tunica avventizia che circonda i vasi e permette anche l’addossamento in essi di nervi e la penetrazione di terminazioni nervose che portano diverse informazioni ai vasi stessi. Nel cuore questa tunica è conosciuta come pericardio.
Vediamo i vari fattori di rilasciamento e di contrazione derivati dall’endotelio che regolano il tono basale delle arterie. Questi fattori influenzano la muscolatura vascolare liscia in modo paracrino
( per spiegare il significato del termine paracrino vi fornisco la definizione già riportata su Wikipedia: “Si definisce paracrino il messaggero chimico prodotto da una cellula che è lasciato diffondere al fine di modificare la fisiologia delle cellule che la circondano.
La distinzione è di solito compiuta tra segnalazione paracrina e autocrina. In entrambi i tipi, il segnale è limitato alle altre cellule nell'area locale, ma la segnalazione paracrina influisce su cellule di tipo differente rispetto alla cellula che ha compiuto la secrezione, mentre quella autocrina influisce su cellule dello stesso tipo.”).
Fattori di rilasciamento EDRF è il gruppo di mediatori endoteliali attraverso cui tutti questi fattori agiscono.
E’costituito prevalentemente da:
(1) Ossido nitrico (NO) o comunque un radicale nitrosile altamente reattivo e a vita brevissima che nelle cellule endoteliali possono generare attravero la NO-sintetasi . L’NO è senza dubbio il più importante di questi radicali ma il termine ossido nitrico può essere usato in senso lato includendo anche gli altri radicali. L’endotelio normale presenta un rilascio continuo di NO. La sua produzione può essere stimolata da parte di numerosi agonisti endoteliali tra i quali acetilcolina (Ach), bradichinina, istamina e trombina. Inoltre la sua produzione può essere indotta da alcune forze meccaniche (la trazione esercitata lungo la superficie endoteliale sullo stesso piano del flusso ematico attraverso il vaso) stimola la produzione di NO e induce anche la produzione di altri fattori di rilasciamento e di alcuni fattori di contrazione. Durante la sua breve vita (5-8 secondi) l’NO esercita i suoi effetti vasorilassanti locali. La sostanza attraversa lo spazio dall’endotelio alle cellule muscolari lisce, dove stimola direttamente la guanilatociclasi solubile e la formazione diguanosinmonofosfato (GMP)ciclico. Quest’ultimo è un secondo messaggero intracellulare per il rilasciamento vasale . L’importanza dell’attività dell’NO nel mantenere normale la pressione arteriosa è stata chiaramente dimostrata . Gli analoghi dell’L-arginina come il L-NMMA inibiscono competitivamente la NO-sintetasi, producendo un rapido e drammatico aumento della pressione arteriosa
(2) Tra gli eicosanoidi, il principale fattore di rilasciamento è la prostaciclina, un dilatatore paracrino prodotto in risposta a molti degli stessi agonisti che stimolano la produzione endoteliale di NO. La sua emivita è inferiore a 1 minuto. Di per sé, la prostaciclina è un potente vasodilatatore ma normalmente ha scarso effetto sulla pressione arteriosa; essa appare invece importante in condizioni di stress biologico, quando la vasodilatazione diviene necessaria per sostenere l’aumento di flusso sanguigno nell’organo interessato.
(3) C’è poi un altro fattore non ancora ben caratterizzato; la sua azione si esplica per iperpolarizzazione della membrana delle cellule muscolari lisce e viene definito fattore di iperpolarizzazione endotelio-derivato (EDHF). Poiché la contrazione della muscolatura liscia implica la depolarizzazione della membrana cellulare, l’EDHF promuove la dilatazione riducendo la sensibilità della membrana agli stimoli depolarizzanti, allo stesso modo degli agonisti vasocostrittori.
Fattori di contrazione Il più potente è l’endotelina 1 che viene sintetizzata nelle cellule endoteliali. L’endotelina 2 è un peptide a 21 aminoacidi correlato alla 1, può essere sintetizzata nelle cellule renali e l’endotelina 3 è presente nel tessuto nervoso. Hanno una azione notevolmente prolungata. L’endotelina 1 non è l’unico fattore di contrazione endotelio-derivato che abbia effetti paracrini e sistemici; l’angiotensina2 agisce come fattore paracrino ma, in condizioni di stenosi delle arterie renali, può essere prodotta in quantità notevole ed entrare in circolo causando ipertensione sistemica. I fattori di rilasciamento endotelio-derivati sembra siano dotati solo di effetti paracrini. Nessun fattore di contrazione di origine endoteliale svolge un ruolo così importante nella modulazione del tono vascolare basale quanto l’NO. Nei vasi normali, uno o tutti i fattori di contrazione conosciuti possono essere bloccati senza provocare una improvvisa caduta della pressione arteriosa. Lo stiramento del vaso (= una forza perpendicolare alla parete vascolare) stimola la produzione di endotelina1 (senza concomitante produzione di fattori di rilasciamento). Eppure anche quando l’endotelio viene rimosso, i vasi sottoposti a stiramento tendono a contrarsi per tornare alla forma originaria. Lo stimolo è meccanico: la parete del vaso sottoposto a stiramento permette al Calcio di fuoriuscire verso le cellule muscolari lisce e indurre la costrizione. L’endotelina1 sembra quindi più importante nel quadro fisiopatologico piuttosto che nella regolazione del tono vascolare momento per momento. Nel determinare il tono vascolare basale le forze meccaniche sembrano esercitare un ruolo più importante di qualsiasi fattore biochimico.
Processi patologici
(1) Ipertensione. Una deficienza di NO endotelio-derivato contribuisce sia all’ipertensione volume correlata che all’ipertensione indotta da costrizione dei vasi di resistenza.
(2) Insufficienza renale acuta e cronica. Un danno ischemico all’endotelio può avere conseguenze cliniche in quanto riduce la capacità di autoregolazione del flusso sanguigno di un organo. Questo vale per tutti gli organi e in particolare per il rene, dove l’insufficienza renale acuta appare prolungata ad opera di episodi ischemici ricorrenti associati a una pur limitata riduzione del flusso arterioso. L’endotelio danneggiato possiede capacità ridotte di generare attività di NO-sintetasi,ma incrementa la propria produzione di endotelina 1 e forse anche di altri vasocostrittori quali radicali liberi, trombossano A2 o angiotensina2. In tal modo, l’endotelio danneggiato riduce ulteriormente il flusso sanguigno e provoca ulteriore danno ischemico a livello renale, sia al sistema vascolare che al parenchima. Questo circolo vizioso può avere implicazioni per i soggetti con insufficienza renale acuta sottoposti a dialisi. Se il sistema vascolare renale è incapace di una normale autoregolazione, un calo della pressione durante la dialisi, anche modesto (fino a 80 mm Hg x 20-30’) può provocare ulteriore danno ischemico. La durata dell’insufficienza renale acuta potrebbe essere abbreviata scegliendo sistemi di dialisi che mantengono relativamente stabile la pressione ed evitano l’ischemia renale ricorrente. Sostanze vasoattive endotelio-derivate possono condizionare la crescita delle cellule mesangiali come della muscolatura liscia. Così una riduzione nell’attività dell’NO combinata con un aumento dell’attività di vasocostrittori quali le endoteline, potrebbe promuovere la patogenesi di alcune forme proliferative di glomerulonefrite.
Aterosclerosi e coronaropatie L’aterosclerosi non è solo un’ostruzione anatomica dei vasi. Il processo patologico induce modificazioni nella biochimica dell’endotelio, che a loro volta sconvolgono le attività fisiologiche del tessuto. Si ipotizza che i lipidi della placca spazzino via l’NO, causando una deficienza nella sua attività. In tal modo, quando una riduzione del flusso ematico in un’arteria coronarica aterosclerotica produce uno stato ischemico transitorio, la mancanza di attività dell’NO priva il vaso della capacità di dilatarsi e lo lascia vulnerabile allo spasmo.
Poichè l’NO è anche un importante inibitore dell’adesione piastrinica, l’allontanamento dell’NO da parte dei lipidi della placca può contribuire anche alla formazione del trombo. Sostanze capaci di indurre un rilasciamento dei vasi quando l’endotelio è intatto ( esempio l’Ach),non hanno effetto o provocano costrizione (l’Ach) quando l’endotelio è rimosso. Quindi l’endotelina 1 può contribuire all’inizio dell’ischemia o può rappresentare una risposta all’ischemia originata da spasmo delle coronarie o dalla presenza di trombi arteriosi. L’infarto coronarico può ridurre la capacità dell’endotelio di produrre NO, e nella conseguente deficienza di azione vasodilatatoria, sono sufficienti piccole variazioni della pressione e dei fattori vasocostrittori per indurre vasospasmo. Infine l’incapacità di modulare il tono vascolare da parte dell’endotelio può essere importante nell’attacco ischemico transitorio (considerato un disordine di tipo vasospastico). Se l’endotelio cerebrovascolare danneggiato non è in grado di produrre sufficiente NO, anche un incremento modesto delle catecolamine o di ormone circolante, ad esempio angiotensina, può produrre vasospasmo, che si manifesta come attacco ischemico transitorio. Nella Sepsi l’endotossina stimola la produzione di citochine , che, a loro volta, inducono l’attività NO-sintetasica. L’ NO che ne risulta può provocare un’eccessiva vasodilatazione. La sovrapproduzione di NO può provocare ipotensione associata allo shock endotossico, lo shock caldo, caratterizzato da improvvisa caduta della pressione non prodotta da una perdita di volume. In questo caso però l’uso ((come farmaco)) di inibitori della NO-sintetasi rimane problematico: l’inibizione dell’attività dell’NO blocca anche la potente azione anticoagulante di questo fattore, lasciando l’organismo esposto agli effetti procoagulanti delle stesse citochine che provocano il rilasciamento dei vasi.
Rimodellamento dell’endotelio.
In alcune circostanze, il danno all’endotelio può essere riparato e il tessuto può riprendere la sua funzione normale.
Un esempio è il danno all’endotelio polmonare causato da ipossia cronica dovuta a permanenza a elevata altitudine; il danno viene riparato e l’attività dell’NO riprende quando il soggetto scende a quote più basse. Il danno causato da aterosclerosi si corregge meno facilmente, specie se il soggetto mantiene un’alimentazione ad alto contenuto di grassi. Finché i lipidi si depositano, l’NO continua ad essere spazzato via. I vasi colpiti da aterosclerosi possono essere liberati meccanicamente mediante l’angioplastica ma il danno alle cellule endoteliali prodotto durante l’angioplastica contribuisce a ulteriori alterazioni patologiche delle arterie e probabilmente l’endotelio perde la capacità di generare attività NO-sintetasica. Secondo un recente studio (2004) l’ipertensione va interpretata come uno stato infiammatorio, infatti la proteina C-reattiva è risultata essere significativamente associata con un aumentato rischio di sviluppare ipertensione in tutti i sottogruppi analizzati. Una sistolica troppo alta segnala un sovraffaticamento del cuore e sottopone a stress i vasi, che potrebbero rompersi; una diastolica troppo alta significa che il cuore e i vasi non si rilassano bene tra un battito e l’altro.
NOTE
(1) Un sintomo che può essere indicativo di pressione alta, soprattutto se insorge da un momento all’altro è la nicturia (cioè il fatto di dover urinare durante la notte); in questo caso la pressione arteriosa rimane alta anche durante il sonno e il rene viene così sollecitato ad un superlavoro e a scaricarsi attraverso le urine.
(2) Tra le analisi del sangue spesso c’è la potassiemia, perché? Perché un eccesso di potassio (K) può essere legato ad ipertensione mentre un livello basso serve a sconsigliare l’uso di diuretici nella terapia.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Informazioni personali

- Marina Salomone
- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone
per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com

















































































































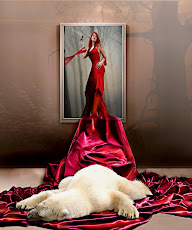

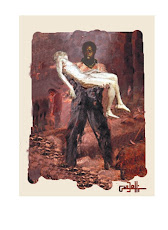

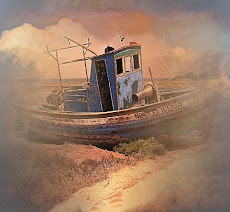

























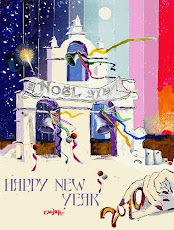
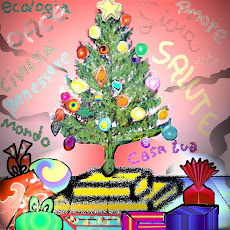












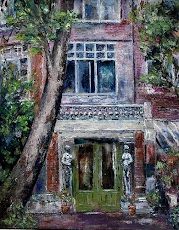







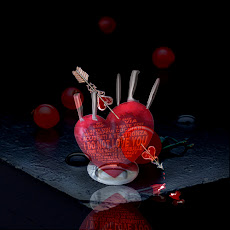














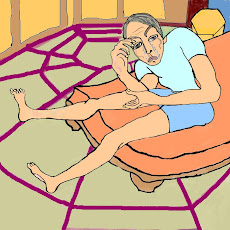























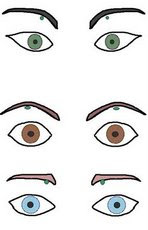
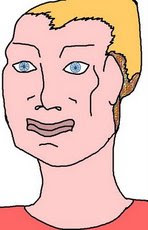







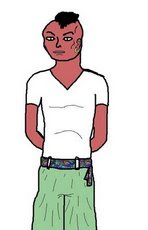
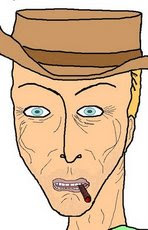





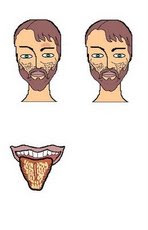
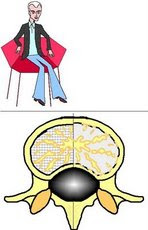
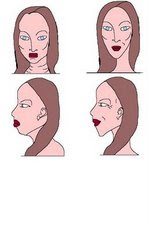

interessante,anche se non di facile lettura in ogni parte
RispondiEliminabuona domenica