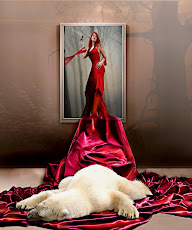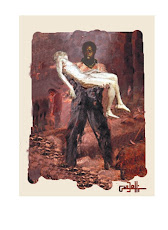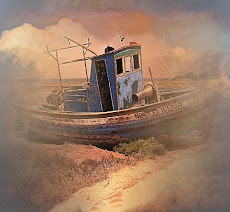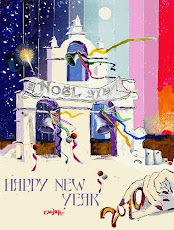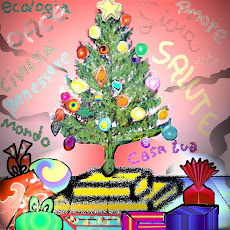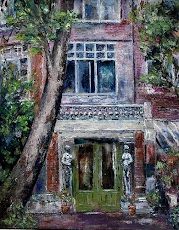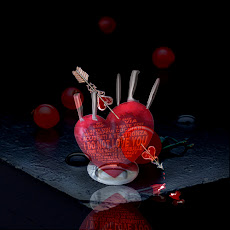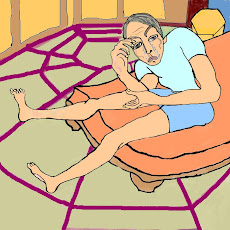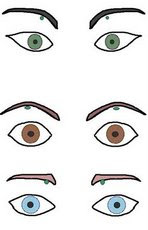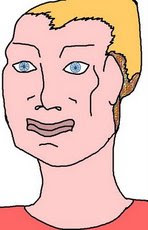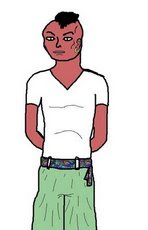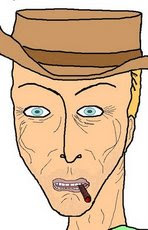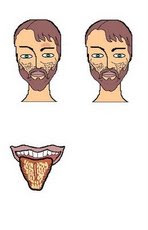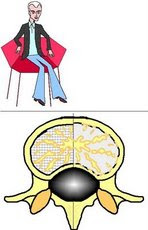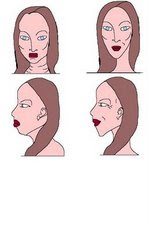lunedì 28 novembre 2016
ARNICA
L’arnica è uno di quei rimedi da tenere sempre in casa, in quanto ha una vastissima gamma di indicazioni.
Agisce su: muscoli, tessuto connettivo, vasi, cuore, stomaco-intestino, pelle. Prima scelta per i disturbi da trauma sia fisico che psichico.
Ecco un elenco delle indicazioni: contusioni, schiacciamenti, distorsioni, ematomi, foruncoli, diatesi emorragica; come sostegno per apoplessie ed emorragie della retina; nevralgie e mialgie in generale, sciatica, varici, stenocardia, ipertensione, arteriosclerosi, debolezza del miocardio; epistassi (perdita di sangue dal naso) tosse, pertosse, afonia, febbre alta, disturbi gastrointestinali.
Ma esiste pure un soggetto di costituzione “Arnica”; si tratta di un soggetto muscoloso, pletorico, ricco di sangue con tendenza a congestioni. In pratica il rimedio fa parte della serie “sulfurica” cioè viene prescritto ai soggetti di costituzione sulfur. Soffre di ipertensione che spesso si manifesta con il mal di testa. Assomiglia moltissimo a Belladonna per le indicazioni di febbre e ipertensione. Entrambi hanno la testa surriscaldata e il corpo freddo. Però mentre belladonna non sopporta la luce, arnica non sopporta di essere toccato. Infatti, anche se non ha avuto un trauma fisico, il sintomo principale è la sensazione di contusione, come se fosse caduto o avesse preso una forte stangata.
Tutte le azioni del rimedio sembrano portare ad una maggiore ossigenazione dei tessuti.
Come rimedio omeopatico alle diluizioni centesimali la dose consigliata è:
—dalla 5 alla 9 CH per i disturbi fisici e/o recenti tre granuli tre volte al giorno
— 15 e 30 CH per i disturbi cronici e/ o iniziati da parecchio tempo
—200 CH e oltre per i disturbi psico-emotivi.
Come rimedio omotossicologico, uno dei più usati è Arnica compositum heel. I rimedi in questo caso sono in diluizione decimale. Ecco cosa contiene: arnica D2, calendula, hamamelis, bellis perennis, hypericum, echinacea angustifolia e purpurea, tutti alla D2, achillea, aconitum e chamonilla alla D3, atropa belladonna alla D4, symphytum , hepar sulfur e mercurius solubilis alla D8.
Da più di 30 anni viene usata con successo per traumi, infiammazioni e processi degenerativi. Da studi in vitro è stato dimostrato che stimola la liberazione di citochine antinfiammatorie, soprattutto TGF-beta. Da qui è stata formulata l’ipotesi che, alla base dell’effetto antinfiammatorio di alcuni farmaci omotossicologici vi possa essere l’innesco e progressione di una reazione immunologica di soccorso. Il farmaco induce la clonazione di un tipo di linfocita che regola l’attività immunitaria (Th3) e che secerne il TGF-beta; la reazione immunologica di soccorso viene avviata da basse concentrazioni di principio attivo.
nota:
normalmente si usano i granuli e l’uso esterno. La tintura madre è da consigliare per un uso che sia solo occasionale o per gargarismi.
Infatti, l’uso prolungato della tintura madre
potrebbe causare ematuria e danno all'epitelio tubulare del rene; inoltre può provocare aumento delle transaminasi e della gammaGT.
domenica 20 novembre 2016
ASMA rimedi omeopatici
Asma
rimedi omeopatici
Riporto un brano tratto da un interessante articolo di Francesco Perugini, pubblicato sulla rivista La medicina biologica gennaio-marzo 2002. I rimedi e il protocollo che descrive sono a mio parere di grande efficacia
Rimedi per sedare la fase acuta
ARSENICUM ALBUM
Asma dopo mezzanotte, stando sdraiato, grande angoscia e irrequietezza. Migliora con il calore.
KALIUM BICHROMICUM
Asma che peggiora dalle 3 alle 4 del mattino; si aggrava con l’esposizione al freddo; muco giallo filamentoso. Cefalea alla radice del naso e ostruzione nasale.
IPECA
Paziente irritabile, capriccioso, insoddisfatto, che non sopporta il freddo e il caldo umido. Sensazione costante di costrizione toracica. Respiro corto con starnuti violenti e incessanti; tosse soffocante senza espettorato, nausea e vomito poco produttivi che non migliorano la situazione. La lingua è pulita e la salivazione abbondante. Durante la crisi si possono avere epistassi ed emottisi o addirittura ematemesi con sangue di colore rosso vivo. Peggiora con il minimo movimento e migliora con il riposo.
NATRIUM SULFURICUM
Asma peggiorato dal tempo umido. Peggioramento alle 4-5 del mattino. Espettorato abbondante, spesso e verdastro.
ANTIMONIUM TARTARICUM
Asma con rantoli di muco nel torace, peggioramento alle 3 del mattino, scarsa espettorazione che non porta sollievo.
SCILLA
Starnuti spasmodici con perdita di urina.
LACHESIS
Crisi d’asma al risveglio e prima di coricarsi con sensazione di costrizione al collo e al torace.
AMMONIUM CARBONICUM
Crisi d’asma intorno alle 3 del mattino caratterizzate da dispnea sibilante, tosse irritante e spasmo bronchiale con difficoltà a respirare.
Irritazione acuta della mucosa respiratoria. Bronchite cronica o cardiopatia. Espettorazione difficile di muco schiumoso, giallastro in caso di crisi da sovrainfezione. Rantoli mucosi e sibilanti. Peggiora con il freddo, soprattutto umido, con il tempo coperto e nebbioso, con il caldo della stanza, con lo sforzo. Migliora con il tempo secco a temperatura moderata, con l’espettorazione.
ACONITUM
Asma favorita da freddo secco, come quello portato dal vento di levante. Agitazione mentale con angoscia e paura di morire. Il paziente si gira continuamente nel letto. La crisi è accompagnata da febbre senza sudore, con sete intensa, tosse secca, tendenza sincopale quando si alza in piedi. La fine della crisi è caratterizzata dalla comparsa di sudore ed espettorazione poco abbondante.
ARALIA
Asma che peggiora con il freddo secco, prima di mezzanotte; spiccata sensibilità alle correnti d’aria. Associata ad un raffreddore da fieno che provoca corizza abbondante ed escoriante. Si aggrava non appena si corica. Espettorazione mucosa di sapore salato difficile da eliminare.
BELLADONNA
Congestione alla testa; ipersensibilità di tutti i sensi; il paziente ha sete ed è molto sensibile al freddo. E’ molto abbattuto non appena si manifesta la crisi di asma; secchezza delle mucose, ma la pelle è umidiccia, soprattutto nelle parti coperte. La crisi è caratterizzata da una tosse abbaiante dolorosa senza espettorato spesso con ostruzione nasale. L’asma peggiora prima di mezzanotte e con il movimento. Migliora con il riposo in ambienti chiusi e caldi.
CINA
Asma del bambino che presenta disturbi nervosi, digestivi e respiratori legati ad una parassitosi intestinale e talvolta alla dentizione. Il bambino è capriccioso, dorme male, digrigna i denti, grida nel sonno, spesso soffre di enuresi. Si frega spesso il naso. Ha una fame da lupo anche dopo mangiato. Spesso presenta una tosse spasmodica, talvolta accompagnata da convulsioni. La crisi d’asma comincia con una tosse di questo tipo; provoca soffocamento e pallore del viso ed è più frequente con la luna piena.
CUPRUM METALLICUM
Soggetti ipersensibili che reagiscono inizialmente in modo violento ma si esauriscono presto. Peggiora con l’aria e il vento freddo e con la luna nuova. Le crisi d’asma possono manifestarsi dopo uno spavento, durante la dentizione o dopo la soppressione di una eliminazione cutanea ( ad esempio esantema o dermatite atopica). Tosse spasmodica, cianosi del viso, nausea, sensazione di costrizione toracica. Il paziente presenta spesso crampi che partono dalle estremità o mioclonie localizzate. Migliora con la traspirazione e bevendo acqua fredda.
DROSERA
Soggetto astenico e freddoloso con appetito irregolare e tendenza alla tosse, alla raucedine, alle adeniti e ai dolori articolari. La crisi è preceduta da una sensazione di secchezza della faringe con difficoltà respiratorie nel parlare e nel tossire. Il volto caldo e le estremità fredde. Durante la crisi, che si verifica a letto dopo mezzanotte, accompagnata da nausea e talvolta epistassi non molto abbondante, il paziente si siede e si tiene l’addome o il petto con le mani; peggiora parlando; migliora aprendo la finestra.
LAUROCERASUS
Asma con ansia e paura di morire; cianosi del viso e raffreddamento generale. Spasmi localizzati o generalizzati; tosse spasmodica con prurito faringeo. Peggiora sdraiato ma migliora con la testa bassa. Soffocamento al minimo sforzo, anche solo per alzarsi a sedere sul letto; sbadigli frequenti; polso molto debole; bisogno di aria.
LOBELIA INFLATA
Pallore del volto, ansia, paura di morire durante la crisi, forte vagotonia con dispnea e oppressione; espettorazione difficile, se non impossibile, ma ipersalivazione frequente; sensazione di costrizione toracica; La crisi è accompagnata da nausea ed eruttazioni con la sensazione di avere un corpo estraneo nella laringe. Peggiora con il movimento, il freddo e il fumo di tabacco. Migliora con il caldo.
NAPHTALINUM
Asma preceduta da tosse spasmodica soffocante con accessi lunghi e ravvicinati. Migliora all’aperto; forte dispnea e presenza nei bronchi di muco denso e difficile da staccare. Non sopporta gli indumenti stretti intorno al torace. La crisi è seguita da un bisogno impellente di urinare.
SAMBUCUS NIGRA
Adatto soprattutto al bambino o neonato debole e nervoso, soggetto a infiammazioni delle narici, senza secrezioni e spasmi della laringe. L'asma è soffocante; peggiora verso mezzanotte, con l’aria fredda e secca, con il movimento. E’ accompagnata da ostruzione nasale, tosse soffocante, agitazione e ansia, traspirazione abbondante del viso.
SENEGA
Indicato per gli anziani malati di bronchite cronica, deboli e tremanti. L'asma è preceduta da una tosse secca e lacerante, respirazione rumorosa con accumulo di muco, oppressione, espettorato nulla o poco abbondante, difficile, che non dà sollievo. Peggiora sdraiato sul fianco sinistro; migliora sdraiato con la testa indietro.
SPONGIA TOSTA
Asma con coriza secca o con muco denso. Ansia con paura di morire durante la crisi che si verifica verso mezzanotte con secchezza o irritazione e bruciore di laringe e trachea; accessi congestizi alla testa; tosse secca, rumorosa, rauca, che ricorda l’abbaiare di un cane o il rumore di una sega da legno. Peggiora in ambienti chiusi e caldi; migliora con bevande tiepide o calde.
AMMONIUM ARSENICOSUM
Tendenza depressiva, stanchezza, agitazione. Forte dispnea; i bronchi sono pieni di muco denso, difficile da espettorare per via della consistenza e anche per la presenza di una paresi respiratoria. La tosse è moderata. Migliora con l’espettorazione. E’ un rimedio di asma per soggetti bronchitici cronici che a volte presentano già un enfisema.
ANTIMONIUM TARTARICUM
Soggetto pallido, stanco o sonnolento che reagisce male (bambino o anziano). Asma con molti rantoli umidi in un soggetto che si sente molto oppresso da sdraiato e che deve sedersi. Spesso ha la nausea e talvolta vomita facendo sforzi penosi per espettorare per via della tendenza alla paresi respiratoria. L’espettorazione gli dà sollievo. Il soggetto presenta spesso sudori freddi; la respirazione è rumorosa; durante l’espirazione le narici sono dilatate. Bisogna usare la 4CH perché le diluizioni troppo alte non favoriscono l’espettorazione.
BLATTA ORIENTALIS
Durante la crisi di asma, caratterizzata da una dispnea soffocante; trova sollievo se riesce a espettorare. E’ indicato nei soggetti corpulenti, pletorici o con ritenzione idrica. Uno dei rimedi di prima scelta in caso di allergia alla polvere, alle muffe e agli acari: 4-5CH nelle forme acute.
COCCUS CACTI è un rimedio di irritazione infiammatoria e spasmodica delle mucose respiratorie con espettorazione di muco abbondante e laringeo, soprattutto prima di mezzanotte o la mattina al risveglio in una stanza calda. Segue la comparsa della dispnea con eliminazione di muco biancastro, abbondante, vischioso e filante. Migliora in piedi, con la finestra aperta e con bevande fredde.
ENGYSTOL è particolarmente indicato per l’asma bronchiale. Svolge un’azione aspecifica di controllo dell’infiammazione ed è in grado di influire sulla liberazione dei superossidi radicalici da parte dei granulociti. Engystol è efficace anche nell’asma allergica e nelle oculoriniti allergiche stagionali. In via preventiva 1 fiala im 2 volte a settimana. E’ particolarmente indicato anche nelle fasi acute.
TARTEPHEDREEL
Si inizia con 10 gocce (2-6 nei bambini più piccoli) ogni 15’ minuti distanziando l’assunzione con il miglioramento. A volte è necessario potenziare l’effetto di questo farmaco con HUSTEEL gocce e DROSERA HOMACCORD gocce; i 3 prodotti possono essere assunti contemporaneamente ad ogni somministrazione o alternati. Nei casi più impegnativi si interviene con la terapia iniettabile a base di Engystol, Cuprum heel e Apis homaccord. Nel caso in cui i sintomi persistono si possono praticare pomfi in zona toracica con 1-2 fiale di FORMICA RUFA D12. Nei bambini la terapia iniettiva è problematica per cui si preferisce la via orale. Come fitoterapia io (F Perugini) consiglio nella fase acuta Efedra, Belladonna, Lobelia. Sebbene meno efficace il Ribes nigrum MG può essere di valido aiuto.
ETHYL SULFUR DICHLORATUM (Iprite)
L’asma è secca o accompagnata da edema polmonare. Il viso è cianotico, l’espettorato è poco abbondante, schiumoso, di colore rosa o sanguinolento. Sensazione di bruciore alla trachea, tosse convulsa, spesso con vomito.
ALTRI RIMEDI:
— HISTAMINUM MURIATICUM;
— POUMON HISTAMINE
— HISTAMINUM;
Dopo aver alleviato lo stato acuto daremo rimedi costituzionali
IL SULFURICO ha reazioni steniche, brevi. Le sue manifestazioni allergiche sono violente, spesso accompagnate da un atteggiamento psichico reattivo, di rifiuto della patologia ad ogni costo. E’ il soggetto che pur di star bene, si rimpinza di farmaci. I rimedi più frequentemente usati per questo tipo costituzionale sono: Sulfur, Sulfur jodatum, Nux vomica, Lycopodium, e altri.
CALCAREA CARBONICA e tipo “carbonico” in generale; è linfatico, con sovrappeso, sovraccarico o incompatibilità alimentari. Caratterizzato da debolezza permanente, lentezza, passività. Soggetto sempre oppresso dalla paura. Va incontro frequentemente ad affezioni respiratorie di tipo catarrale, affezioni della sfera ORL, dermatosi e dermatiti, sinusiti e tossi ribelli. E’ sensibile a freddo e a umido. Caratterizzato da debolezza permanente, lentezza, passività. Soggetto sempre oppresso dalla paura. I rimedi più frequentemente indicati per questo tipo costituzionale sono: calcarea carbonica, thuja, natrum sulfuricum, antimonium crudum, baryta carbonica, lycopodium, dulcamara.
IL FOSFORICO va facilmente incontro ad affezioni allergiche, a causa della sua demineralizzazione, del ricambio idroelettrolitico insufficiente, della sensibilità termica, della insufficienza epatodigestiva, delle affezioni intestinali e del sistema immunitario. E’ inoltre un soggetto dallo psichismo labile, che reagirà con manifestazioni allergiche anche ad “antigeni psichici “ che potranno essere cause scatenanti di una crisi allergica. Ha reazioni vive e precoci. Sarà perciò tra i primi a sentire i primi pollini quando inizia la stagione. I rimedi più frequentemente indicati per questo tipo costituzionale sono calcarea phosphorica, phosphorus, arsenicum album, sulfur jodatum, pulsatilla, silicea, natrum muriaticum.
IL FLUORICO è un soggetto iperattivo con riflessi instabili e disordinati. Sensibile in particolare agli allergeni microbici, fungini, acari e muffe. Le sue reazioni sono di tipo vascolare, asmatico, con frequenti sovrapposizioni infettive. I rimedi più frequentemente prescritti per questo tipo costituzionale sono calcarea fluorica, fluoricum acidum, aurum.
TERAPIA DESENSIBILIZZANTE IN CASO DI ASMA DA ALLERGIE
diluizioni crescenti di miscele di pollini omeopatizzati, iniziando circa 3 mesi prima dell’insorgenza dei primi sintomi. Il primo mese faccio assumere un pool pollinico in D6 tutte le mattine; il secondo mese lo stesso pool in D15 a giorni alterni e dal terzo mese per tutto il periodo prima dei pollini in D30 a giorni alterni oppure ogni 2 giorni . FORMICA RUFA è un altro farmaco desensibilizzante. Si praticano iniezioni sc o in autoemoterapia per via im e sempre con largo anticipo rispetto alla sintomatologia prevista nel caso di: asma allergico D6 1 volta a settimana per 2-3 settimane, continuare con D12; in caso di rinite allergica D12 1 volta al mese.
domenica 13 novembre 2016
ALIMENTAZIONE tre note
VITAMINE
Ecco una nota importante sulla conservazione:
il contenuto vitaminico dei surgelati è maggiore di quello dello stesso ortaggio comperato fresco e tenuto nel frigorifero per una settimana prima di consumarlo.
I surgelati non devono essere scongelati prima della cottura per mantenere il miglior contenuto di vitamine.
La cottura in acqua mantenendo la buccia (patate, pere, mele) evita molte perdite vitaminiche. Con la frittura le patate perdono il 21% della vitamina C, e piccole perdite di vitamina A e beta-carotene.
In generale oltre alla perdita di vitamine con la cottura, c’è un’ulteriore perdita quando gli avanzi vengono messi in frigo ed una ancora quando, un giorno dopo, vengono riscaldati.
Esempio: asparagi cotti di fresco vitamina C= 14%
refrigerati = -18%
riscaldati il giorno dopo= - 34%.
Ecco perché è importante cercare di non fare avanzare cibi cotti per consumarli il giorno dopo.
Quanto al fatto di variare la dieta questo è importante per garantirsi il maggior apporto di micronutrienti.
FIBRE
La mucosa dell’intestino produce in modo continuo acqua, elettroliti e muco nel lume dell’organo per lubrificare e veicolare il contenuto intestinale fino al colon dove vengono riassorbiti gran parte dei liquidi secreti. Quindi il materiale fecale che giunge nelle parti più distali del colon si trova praticamente allo stato solido. Se poi, per motivi di transito rallentato, le feci permangono nel colon per un tempo prolungato, l’estrazione di acqua è ancora maggiore ed esse possono diventare particolarmente secche e difficili da evacuare. Ogni giorno arrivano nel colon circa 500 ml di materiale fecale di consistenza semi-liquida, e da qui vengono evacuati quotidianamente dai 50 ai 250 g di feci in buona parte disidratate e solide. La composizione delle feci espulse è simile a quella del materiale fecale prodotto dall’intestino tenue al termine della digestione, ovvero acqua, residui cellulari, batteri, alimenti non digeribili come le fibre e piccole percentuali indigerite di idrati di carbonio, lipidi e proteine. La defecazione si compie dopo circa 12-24 ore dall’ingestione del cibo quando, in seguito al progressivo immagazzinamento dei prodotti di scarto della digestione nel retto, le pareti di quest’organo si contraggono intensamente e gli sfinteri anali si rilasciano. Quando, per vari motivi, queste sostanze di rifiuto rimangono nel tratto intestinale più del dovuto vanno incontro a processi di putrefazione, producendo tossine ed altri composti potenzialmente dannosi che, assorbiti, determinano col tempo una vera e propria intossicazione dell’organismo, abbassando le difese immunitarie e provocando uno stato di stanchezza cronica.
Una delle cause più comuni che aumentano il tempo di contatto tra le sostanze digerite e le pareti dell’intestino è senza dubbio la stipsi. L’eccessiva compattezza delle feci conseguente alla disidratazione comporta la loro emissione con sforzo, e il timore di dover affrontare una defecazione prolungata e a volte dolorosa aggrava ulteriormente la condizione, portando il soggetto, consapevole o meno, a trascurare o reprimere lo stimolo determinando così una cronicizzazione della stipsi. D’altra parte il termine stipsi è spesso frainteso da quei soggetti che evacuano meno di quanto vorrebbero, ma sempre con ritmi fisiologici, e che di conseguenza abusano di lassativi creando di fatto uno stato di stipsi cronica.
I vari componenti della fibra possono essere classificati in base al loro comportamento in acqua: i polisaccaridi che gelificano, come ad esempio le mucillagini, sono definiti fibre solubili, mentre i componenti strutturali della parete cellulare dei vegetali, come la cellulosa e la lignina, che mantengono immodificata la propria struttura al contatto con l’acqua, vengono definite fibre insolubili. Tutte le fibre sono necessarie all’organismo umano per mantenere le normali funzioni gastrointestinali; tuttavia le diverse proprietà chimico-fisiche di queste due principali tipologie di fibre --solubili e insolubili-- influenzano in maniera differente i molteplici aspetti della fisiologia digestiva. Grazie alla loro struttura scivolosa e trasudante di liquido, nel corso del loro avanzamento attraverso l’intestino le fibre solubili promuovono l’idratazione della massa fecale favorendo la formazione di feci morbide in grado di transitare agevolmente lungo il tratto intestinale e stimolando, nel contempo, i fisiologici movimenti peristaltici. Inoltre, il gel naturale si stratifica sulla superficie delle mucose ricoprendo la parete intestinale di una sottile pellicola protettiva ad effetto emolliente e lenitivo, utile in caso di mucose irritate ed infiammate. Appartengono al gruppo delle fibre solubili le mucillagini, le pectine, le gomme vegetali, alcuni oligosaccaridi e le emicellulose solubili. Tra le principali fonti alimentari di fibre solubili abbiamo la frutta , soprattutto MELE e AGRUMI, alcuni cereali come l’AVENA, i legumi, i semi di PLANTAGO e di LINO, le radici, foglie e fiori delle malvacee (ALTEA e MALVA) e delle tiliacee (TIGLIO), la radice di CICORIA (= Cycorium intybus da cui si estrae l’INULINA), la radice di AMORPHOTALLUS KONJAK da cui si estrae il GLUCOMANNANO . Sempre legate alle loro proprietà assorbenti sono gli effetti ipocolesterolemizzanti e ipoglicemizzanti e di riduzione dell’assimilazione di cibo di queste fibre, che vengono anche indicate per questi tre casi quando occorre da sole o in sinergia con altri rimedi.
PROBIOTICI
L’INULINA è una fibra vegetale non digeribile ed idrosolubile. E’ composta da unità fruttosio tra loro legate per mezzo di atomi di ossigeno, in modo da costituire una corta struttura polisaccaridica di 30-40 unità, nota anche come dahlina o alantina. Essa ha un alto potere di rigonfiamento in presenza di acqua. In questo modo, provvedendo ad un aumento della massa fecale, assicura un ridotto tempo di transito intestinale, dato che esiste una precisa correlazione tra peso delle feci e tempo di ingombro delle medesime. Contemporaneamente, l’inulina serve da alimento preferenziale per i batteri intestinali, in special modo per i bifidobatteri. Con l’aumentata presenza dei bifidobatteri si innesca una cascata di effetti positivi che va ben oltre il semplice aumento della peristalsi cui si è accennato. Precisamente si ha un aumento della produzione dell’enzima beta-D- galattosidasi
( la cui carenza è stata osservata nei pazienti con morbo di Crohn), una aumentata capacità di eliminazione delle scorie azotate, un aumento della presenza, nel lume intestinale, di acidi carbossilici a corta catena nonché di peptidi ad attività batteriocinico-simile aventi la capacità di inibire la crescita di ceppi batterici indesiderati in eccessiva quantità (come ad esempio Clostridia) ed, infine, un riequilibrio del valore del pH endoluminale. Le fibre inuliniche sono anche in grado di favorire l’assorbimento del Ferro e del Calcio, di inibire il riassorbimento colesterolico e di ridurre l’induzione infiammatoria e degenerativa della mucosa intestinale proprio perché in grado di diminuire il tempo di contatto di questa con le scorie metaboliche circolanti. Ricordiamo che secondo molti autori il prolungato tempo di permanenza del chimo nell’intestino (dipendente da un’alimentazione povera di fibre) è uno dei più importanti fattori di rischio per lo sviluppo del carcinoma del colon.
Altre piante ricche di inulina sono: TOPINAMBOUR, TARASSACO, AGLIO, ASPARAGO, BARDANA e GIRASOLE. L’inulina è contenuta nell’integratore INUVITAL che trova impiego soprattutto nella stipsi.
domenica 6 novembre 2016
SISTEMA IMMUNITARIO storia horror-humor
Una storiella horror-humor facile facile per capire come funziona
Premessa
Il sistema immunitario è un sistema molto complesso, che l'organismo ha creato con il trascorrere del tempo in base al suo rapporto con l'ambiente.
I virus, i batteri, i funghi, i parassiti hanno sempre convissuto con l'uomo. Gli stessi mitocondri delle nostre cellule sono antichi batteri: eppure senza di essi noi non potremmo esistere!
Dal punto di vista olistico perciò non ci interessa fare una guerra mirata contro un dato microrganismo. Ci interessa coltivare un corpo sano che reagisce in modo appropriato contro le invasioni pericolose.
Comincio qui una serie di articoli che scriverò di tanto in tanto, su come funziona il sistema immunitario.
Un argomento molto complesso e ricco di sinonimi e ridondanze che generano ancora più confusione di quanta non ce ne sia già alla base.
Dunque ho voluto semplificare.
Ogni semplificazione comporta il fatto di dover trascurare certi dettagli e il fatto di enunciare inesattezze, ma tutto questo verrà corretto a tempo debito negli approfondimenti successivi.
Dunque ciò che ci interessa esplorare è in che modo il sistema immunitario si difende quando gli ospiti producono disturbi più o meno gravi.
Dopo la storiella inserisco la descrizione scientifica corrispondente in modo che quando leggerete testi sull'argomento potrete ricordare la metafora che lo semplifica.
Gli alieni nel pianeta di Papalla
Il paese di Papalla era un luogo bellissimo, ricco di colori, musica, odori e tutto ciò che si possa immaginare per una vita serena. Gli abitanti erano numerosi e di tanti tipi, ma tutti avevano in comune una forma sferica oppure ovale, oppure di figure geometriche piatte come cerchi, quadrati, triangoli ed esagoni.
Un giorno su questo grande pianeta atterrò un'astronave e scesero tre uomini, lasciando a bordo ad attenderli una squadra di esperti.
Gli uomini cominciarono a passeggiare guardandosi intorno.
“Che bel posto accogliente” disse il primo
“Si respira proprio come sulla terra”, disse il secondo
“Guarda queste bacche rosse— disse il terzo— Il mio analizzatore istantaneo dice che sono commestibili e pure molto gustose, ora ne assaggio una”.
Detto questo assaggiò una bacca rossa sotto lo sguardo inorridito di tutte le altre bacche rosse che videro annientare la loro sorella. Così le bacche cominciarono a gridare aiuto, ma, naturalmente, in una lingua e in un modo che era impossibile percepire da parte degli uomini.
Così in pochi minuti arrivarono i macrofagi e i polinucleati, esseri ben più grandi delle bacche rosse e ben più grandi degli uomini, che svolgevano il lavoro di difensori del pianeta.
Tre di questi, in una semplice e rapida mossa inglobarono gli uomini nel loro corpo sferico e così in un primo tempo, tornò la tranquillità sul pianeta.
Ma ecco che gli esperti rimasti sull'astronave, rimasti a loro volta inorriditi, decidono di inviare una piccola squadra armata per liberare i loro colleghi.
Appena scendono vedono un polinucleato e cominciano a sparare.
“Che stupidi alieni”, pensa il polinucleato, “intanto tu mi hai provocato e io me te magno!”
È, detto fatto, lo ingloba in un sol boccone.
Intanto dall'astronave, nei giorni seguenti, cominciano a scendere altri uomini.
Appena atterrati quale non è il loro agghiacciante senso di orrore nel vedere alcuni grossi esseri sferici che vanno in giro ornati sulla loro superficie, di pezzi umani interi: braccia, gambe, mani, piedi, teste o solo occhi!
Che cosa era questa macabra visione?
Semplice era la presentazione dell'antigene al complesso di istocompatibilità. I difensori del pianeta ora presentavano i pezzi di ciò che avevano distrutto in modo che i linfociti, delle bellissime sfere bianche lucenti, potessero riconoscerli e distruggerli su larga scala senza che i polinucleati fossero costretti alla fatica di mangiarli uno per uno.
Descrizione scientifica
IMMUNITA’ cellulare --> macrofagi e granulociti polinucleati
IMMUNITA’ UMORALE -->(sostanze presenti nel siero) --> complemento (diverse molecole a cascata)
Immunità non specifica--> fagocitosi e complemento
Immuntà specifica --> anticorpi e linfociti T
da un altro punto di vista: immunità umorale è abbinata a immunità non specifica
e immunità cellulare è abbinata a immunità specifica.
Oggi si sa che al momento del suo legame con l’antigene specifico, l’anticorpo si deforma e ciò permette alla prima molecola della cascata del complemento di ancorarsi. Questo legame induce quello di altre molecole della cascata che si organizzano nella membrana della cellula batterica dando origine ad un poro dal quale esce il contenuto cellulare. Gli epiteli ciliati della mucosa polmonare esercitano anche una difesa chimica, grazie ad enzimi come il lisozima o a sostanze come le lectine che negli alveoli polmonari bloccano i batteri mediante appositi gruppi glucidici.
Quando però questa prima barriera è superata, entrano in azione i meccanismi cellulari e molecolari non specifici: fagocitosi da parte dei macrofagi e dei neutrofili polinucleati, reazione infiammatoria, intervento dei linfociti natural killer (NK), sintesi di interferoni contro i virus, attivazione delle molecole della cascata del complemento. La mobilitazione dei meccanismi specifici è più lenta e richiede parecchi giorni prima di essere efficace contro un agente patogeno che l’organismo non ha mai incontrato. Questi meccanismi specifici sono affidati ai linfociti che si dividono in due grandi categorie (oltre ai NK che costituiscono una classe a parte): i linfociti B, responsabili della sintesi degli anticorpi e i linfociti T che esprimono sulla propria superficie molecole di riconoscimento, i recettori T . La maggior parte delle cellule del sistema immunitario deriva da ceppi cellulari comuni che sono prodotti in permanenza nel midollo osseo. Queste cellule interagiscono con diversi fattori di crescita e citochine e, in funzione di questi processi, si differenziano in svariati precursori che daranno origine alle principali linee cellulari: globuli rossi (linea eritrocitaria), piastrine (linea megacariocitaria) e leucociti che comprendono i granulociti polinucleati (o polimorfonucleati), i monociti-macrofagi e i linfociti. I granulociti rappresentano il 60-70% dei leucociti; si distinguono in neutrofili, che esercitano funzioni di fagocitosi e sono i più numerosi, seguiti dagli eosinofili e dai basofili. I basofili mediano le reazioni allergiche violente (ipersensibilità immediata); gli eosinofili hanno un ruolo importante nella protezione dei parassiti (oltre che nelle comuni allergie tipo pollinosi, orticaria ecc). I granulociti sono agenti dell’immunità innata non specifica. Tuttavia, grazie alla presenza sulla loro superficie di recettori specifici delle immunoglobuline (recettori Fc o FcR) , possono ancorare anticorpi che conferiscono loro una specificità passiva. Questi anticorpi stabiliscono collegamenti specifici tra l’agente patogeno da essi riconosciuto (un batterio, per esempio ) e il leucocita sul quale sono fissati. E’ il fenomeno dell’opsonizzazione, che aumenta l’efficacia della fagocitosi e la capacità distruttiva nei confronti del patogeni. I monociti e i macrofagi rappresentano un’altra categoria di cellule fagocitarie e svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella “presentazione” degli antigeni ai linfociti durante la risposta immunitaria. Le cellule che presentano gli antigeni “elaborano” le proteine estranee ingerite ed espongono sulla propria superficie i peptidi antigenici che ne derivano. Per essere riconosciuti dai linfociti T, questi peptidi devono essere presentati in associazione con le molecole di istocompatibilità (le molecole del sé). I linfociti T-CD4 riconoscono i peptidi antigenici presentati dalle molecole di tipo II del complesso maggiore di istocompatibilità, mentre i linfociti T-CD8 riconoscono quelli associati alle molecole di tipo I.
Gli altri agenti importanti dell’immunità innata sono i NK, linfociti di grandi dimensioni. Essi si differenziano nel midollo osseo e passano in circolo senza accumularsi negli organi linfoidi secondari (= linfonodi e milza). Le cellule NK sono capaci di distruggere le cellule infettate da un virus o alcune cellule tumorali grazie a un tipo di riconoscimento che non necessita della presentazione da parte delle molecole del complesso maggiore di istocompatibilità. Quando le sostanze (granzimi, perforine) contenute nei granuli delle cellule NK vengono liberate, si assemblano a formare pori nelle cellule bersaglio, che vanno così incontro a lisi. In più si legano agli anticorpi (IG) che le rendono citotossiche.
Questo dato, insieme ad altri dimostra che i limiti tra immunità naturale e acquisita sono vaghi.
I globuli bianchi rimanenti (30%) sono i linfociti ai quali sono affidati i meccanismi di riconoscimento specifico del sistema immunitario.
Linfociti B (dall’inglese Bone Marrow= midollo osseo dal quale hanno origine) e linfociti T (perché provengono dal Timo, nel quale vengono “istruiti”). I linfociti T, pure provengono dal midollo osseo, ma compiono il loro differenziamento nel timo.
I linfociti B sintetizzano gli anticorpi, chiamati immunoglobuline, che esprimono sulla propria superficie. Il legame degli antigeni con questi anticorpi specifici provoca la stimolazione dei linfociti che li espongono e di conseguenza il differenziamento dei linfociti B in plasmociti, cellule specializzate nella produzione di IG circolanti nel sangue. I linfociti T portano i recettori T, i quali riconoscono gli antigeni a condizione che siano correttamente presentati. Gli antigeni vengono dapprima inglobati da una cellula deputata alla loro presentazione, per esempio un macrofago. All’interno di questa cellula la proteina è tagliata in peptidi dagli enzimi; poi questi peptidi sono affidati a molecole codificate dal complesso maggiore di istocompatibilità e migrano verso la superficie della cellula presentatrice. E’ l’insieme di peptide e molecola del complesso maggiore di istocompatibilità che riconosce il recettore T.
I linfociti T sono a loro volta suddivisi in parecchie sottopopolazioni dalle funzioni differenti. Si distinguono due grandi categorie in funzione della presenza sulla loro superficie di molecole CD4 o CD8. I CD4 sono chiamati ausiliari o helper perché aiutano altri linfocitiT o B a mobilitarsi nella risposta immunitaria. Essi agiscono liberando citochine, molecole dall’effetto modulatore che agiscono sia localmente sia a distanza. I CD8 sono tossici: essi distruggono, per esempio, le cellule infettate da un virus. A questo scopo si utilizzano parecchi meccanismi di citotossicità che si basano sia sull’impiego di perforine che di granzimi, sia sull’avvio del programma di morte cellulare che porta la cellula bersaglio a distruggersi per apoptosi. I linfocitiT-helper si suddividono in TH1 e TH2. L’orientazione verso l’una o l’altra di queste popolazioni è dipendente da una rete di citochine. Il midollo osseo e il timo costiuiscono gli organi linfoidi primari; i gangli linfatici, la milza e le placche di Peyer rappresentano gli organi linfatici secondari o periferici e sono la sede dello sviluppo delle risposte immunitarie. Il differenziamento negli organi linfoidi primari è indipendente dagli antigeni estranei, mentre le reazioni immunitarie ne dipendono fortemente. Il panorama su ciò che viene riconosciuto come estraneo è molto vario. Ad esempio l’”estraneo” può provenire dall’organismo stesso: è il caso delle cellule tumorali, che molto spesso esprimono sulla propria superficie antigeni specifici e quindi costituiscono bersagli che l’organismo deve eliminare il più rapidamente possibile. Tuttavia queste cellule acquisiscono a volte proprietà tali che il sistema immunitario non riesce più a “vederle”. Ad esempio esse perdono la capacità di esprimere le molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (che nell’uomo è indicato con la sigla HLA) in modo che i loro antigeni non vengono più presentati correttamente. Si vede così quanto siano importanti le cellule NK, capaci di riconoscere un nemico anche quando i suoi antigeni non vengono presentati dalle molecole del complesso maggiore di istocompatibilità.
Nel corso del periodo neonatale o fetale il sistema immunitario impara a riconoscere il proprio ambiente, quale che sia la sua origine, genetica o importata: il riconoscimento è dunque una funzione acquisita.
Ciò è stato visto con un esperimento di Medawar: quando un topo di ceppo B riceve, alla nascita, cellule della milza di un topo di ceppo A, diventa capace, da adulto, di accettare un trapianto (ad esempio di cute) proveniente da un donatore di ceppo A. Questa situazione di tolleranza si mantiene per tutta la vita.
Durante la fase di differenziazione la maggior parte dei linfociti che arrivano a maturazione esprimono immunoglobuline di forte affinità per gli antigeni estranei che potranno prima o poi essere incontrati (o che non saranno mai incontrati). Ma si conservano anche dei linfociti che hanno una certa affinità per gli antigeni del sé: debole, certo, ma non nulla. Questo implica l’esistenza di uno stato di autoimmunità fisiologica, non dannoso per l’organismo, ma che sembra indispensabile per il mantenimento di uno stato permanente di vigilanza: un sistema in stato di veglia è più veloce da attivare di uno totalmente a riposo.
martedì 1 novembre 2016
Raffreddore
Eccoci arrivati alla stagione classica del raffreddore . I continui sbalzi termici nel trovarsi tra ambienti ben riscaldati e tratti di strada esposti al freddo sono una delle cause principali nello scatenarsi del raffreddore. Tutti sappiamo che si tratta di un disturbo da virus, ma in condizioni di stabilità ed equilibrio lo stesso virus con cui entriamo in contatto non ci disturba con i sintomi che ben conosciamo. Una buona norma è sicuramente quella di potenziare le nostre difese immunitarie. Ecco dunque alcuni rimedi particolarmente adatti:
Echinacea Angustifolia, Uncaria Tomentosa, Vincetoxinum officinalis, lisato di fegato di anas barbarie, Propoli.
Se ciò non bastasse, alla comparsa dei primi sintomi
quali: astenia, congestione nasale, inappetenza, cefalea,
dolori osteoarticolari e muscolari, febbre, tosse,perdita della voce, si possono assumere rimedi omeopatici-omotossicologici specifici.
Allium Cepa: per crisi di starnuti violenti e continui, con
abbondante secrezione nasale acquosa e lacrimazione non irritante.
Euphrasia: per crisi di starnuti con abbondante secrezione fluida, chiara, non escoriante il naso, lacrimazione abbondante che irrita gli occhi e fotofobia.
Sabadilla: per secrezione nasale abbondante, fluida con starnuti parossistici, lacrimazione abbondante ma non irritante.
Arnica Montana: per quella sensazione di malessere generale con dolori osteo-muscolari.
Belladonna: quando l’inizio è improvviso e violento dopo esposizione a correnti di aria fredda, con naso gonfio, arrossato, dolente e caldo, con secrezione scarsa e gola secca.
Aconitum: nella febbre, quando l’esordio è acuto ed improvviso dopo esposizione a vento freddo, ma secco.
TOSSE
Improvvisa, acuta, secca, a piccoli accessi, con sensazione di soffocamento.
Essa è un riflesso spesso incontrollabile dovuto ad un’irritazione della mucosa causata dall’infiammazione delle vie aeree.
I rimedi più efficaci potranno essere i seguenti.
Bryonia: quando compare dopo esposizione ad umidità, profonda e dolorosa che scuote il corpo, aggravata dal movimento.
Drosera: secca e spastica a lunghi accessi.
Rumex: secca insistente e spossante, con sensazione di solletico in gola.
Sambucus Nigra: secca, spasmodica, pertussoide, con inspirazione sibilante.
Senega: secca e irritante, con scarsissimo espettorato.
Coccuc Cacti : rimedio della tosse spasmodica, con catarro mucoso molto abbondante.
Ed ecco infine alcuni rimedi utilissimi nella laringite, infiammazione generalmente virale della laringe caratterizzata da un abbassamento importante della voce, che può aggravarsi fino a rendere afoni: Aurum Triphyllum, Argentum Nitricum, Nux Vomica, Causticum.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Informazioni personali

- Marina Salomone
- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone
per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com