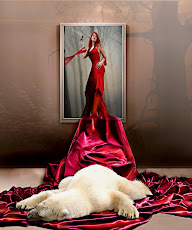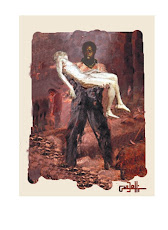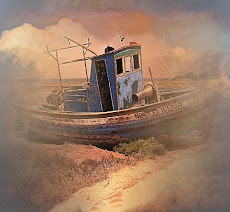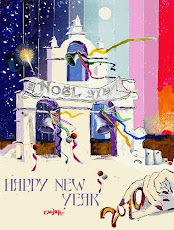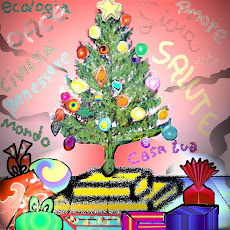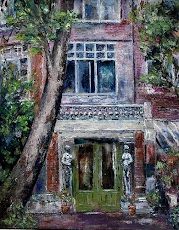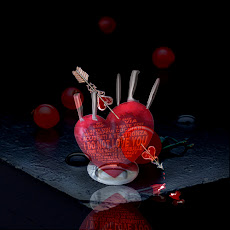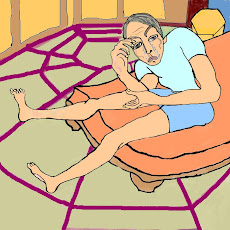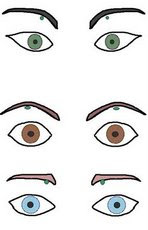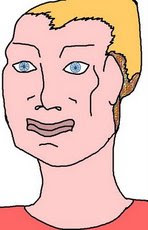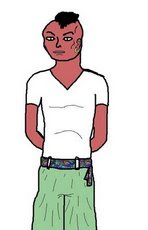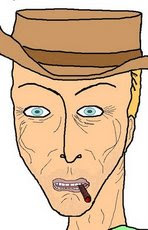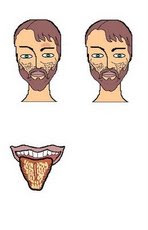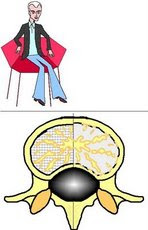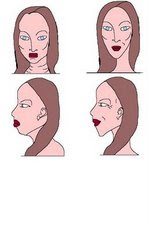Regolazione del tono vascolare a livello endoteliale
sabato 17 maggio 2014
IPERTENSIONE parte seconda
Regolazione del tono vascolare a livello endoteliale
L’endotelio è quella pellicola che fodera l’interno dei vasi e del cuore stesso dove prende il nome di endocardio. Si tratta di un tessuto molto attivo che tra le tante azioni di cui si incarica ha quella di intervenire sul tono vascolare.
Il tono vascolare basale è il grado di contrazione della parete muscolare dei vasi in condizioni basali cioè a riposo. Infatti, ovviamente, in condizioni di sforzo o di forti emozioni, le arterie possono allargare il loro diametro per permettere un maggiore afflusso di sangue negli organi dove necessita e ai muscoli. In pratica si ha una attivazione maggiore del sistema nervoso simpatico con produzione di adrenalina e NA e viene messo in moto tutto il sistema di emergenza dell’organismo per poter “fuggire o attaccare”. Durante uno sforzo, una corsa e ancor più una vera fuga, la pressione arteriosa aumenta parecchio e questo è un fatto fisiologico. Diventa patologico se aumenta quando non occorre e cioè in condizioni di riposo o durante un’attività sedentaria.
I vasi sono costituiti da tre strati concentrici: il più interno è appunto l’endotelio e nel cuore l’endocardio; lo strato intermedio, che è anche il più spesso, è il mesotelio e nel cuore il miocardio costituito da tessuto muscolare; il più esterno, che potremmo definire esotelio, è la tunica avventizia che circonda i vasi e permette anche l’addossamento in essi di nervi e la penetrazione di terminazioni nervose che portano diverse informazioni ai vasi stessi. Nel cuore questa tunica è conosciuta come pericardio.
Vediamo i vari fattori di rilasciamento e di contrazione derivati dall’endotelio che regolano il tono basale delle arterie. Questi fattori influenzano la muscolatura vascolare liscia in modo paracrino
( per spiegare il significato del termine paracrino vi fornisco la definizione già riportata su Wikipedia: “Si definisce paracrino il messaggero chimico prodotto da una cellula che è lasciato diffondere al fine di modificare la fisiologia delle cellule che la circondano.
La distinzione è di solito compiuta tra segnalazione paracrina e autocrina. In entrambi i tipi, il segnale è limitato alle altre cellule nell'area locale, ma la segnalazione paracrina influisce su cellule di tipo differente rispetto alla cellula che ha compiuto la secrezione, mentre quella autocrina influisce su cellule dello stesso tipo.”).
Fattori di rilasciamento EDRF è il gruppo di mediatori endoteliali attraverso cui tutti questi fattori agiscono.
E’costituito prevalentemente da:
(1) Ossido nitrico (NO) o comunque un radicale nitrosile altamente reattivo e a vita brevissima che nelle cellule endoteliali possono generare attravero la NO-sintetasi . L’NO è senza dubbio il più importante di questi radicali ma il termine ossido nitrico può essere usato in senso lato includendo anche gli altri radicali. L’endotelio normale presenta un rilascio continuo di NO. La sua produzione può essere stimolata da parte di numerosi agonisti endoteliali tra i quali acetilcolina (Ach), bradichinina, istamina e trombina. Inoltre la sua produzione può essere indotta da alcune forze meccaniche (la trazione esercitata lungo la superficie endoteliale sullo stesso piano del flusso ematico attraverso il vaso) stimola la produzione di NO e induce anche la produzione di altri fattori di rilasciamento e di alcuni fattori di contrazione. Durante la sua breve vita (5-8 secondi) l’NO esercita i suoi effetti vasorilassanti locali. La sostanza attraversa lo spazio dall’endotelio alle cellule muscolari lisce, dove stimola direttamente la guanilatociclasi solubile e la formazione diguanosinmonofosfato (GMP)ciclico. Quest’ultimo è un secondo messaggero intracellulare per il rilasciamento vasale . L’importanza dell’attività dell’NO nel mantenere normale la pressione arteriosa è stata chiaramente dimostrata . Gli analoghi dell’L-arginina come il L-NMMA inibiscono competitivamente la NO-sintetasi, producendo un rapido e drammatico aumento della pressione arteriosa
(2) Tra gli eicosanoidi, il principale fattore di rilasciamento è la prostaciclina, un dilatatore paracrino prodotto in risposta a molti degli stessi agonisti che stimolano la produzione endoteliale di NO. La sua emivita è inferiore a 1 minuto. Di per sé, la prostaciclina è un potente vasodilatatore ma normalmente ha scarso effetto sulla pressione arteriosa; essa appare invece importante in condizioni di stress biologico, quando la vasodilatazione diviene necessaria per sostenere l’aumento di flusso sanguigno nell’organo interessato.
(3) C’è poi un altro fattore non ancora ben caratterizzato; la sua azione si esplica per iperpolarizzazione della membrana delle cellule muscolari lisce e viene definito fattore di iperpolarizzazione endotelio-derivato (EDHF). Poiché la contrazione della muscolatura liscia implica la depolarizzazione della membrana cellulare, l’EDHF promuove la dilatazione riducendo la sensibilità della membrana agli stimoli depolarizzanti, allo stesso modo degli agonisti vasocostrittori.
Fattori di contrazione Il più potente è l’endotelina 1 che viene sintetizzata nelle cellule endoteliali. L’endotelina 2 è un peptide a 21 aminoacidi correlato alla 1, può essere sintetizzata nelle cellule renali e l’endotelina 3 è presente nel tessuto nervoso. Hanno una azione notevolmente prolungata. L’endotelina 1 non è l’unico fattore di contrazione endotelio-derivato che abbia effetti paracrini e sistemici; l’angiotensina2 agisce come fattore paracrino ma, in condizioni di stenosi delle arterie renali, può essere prodotta in quantità notevole ed entrare in circolo causando ipertensione sistemica. I fattori di rilasciamento endotelio-derivati sembra siano dotati solo di effetti paracrini. Nessun fattore di contrazione di origine endoteliale svolge un ruolo così importante nella modulazione del tono vascolare basale quanto l’NO. Nei vasi normali, uno o tutti i fattori di contrazione conosciuti possono essere bloccati senza provocare una improvvisa caduta della pressione arteriosa. Lo stiramento del vaso (= una forza perpendicolare alla parete vascolare) stimola la produzione di endotelina1 (senza concomitante produzione di fattori di rilasciamento). Eppure anche quando l’endotelio viene rimosso, i vasi sottoposti a stiramento tendono a contrarsi per tornare alla forma originaria. Lo stimolo è meccanico: la parete del vaso sottoposto a stiramento permette al Calcio di fuoriuscire verso le cellule muscolari lisce e indurre la costrizione. L’endotelina1 sembra quindi più importante nel quadro fisiopatologico piuttosto che nella regolazione del tono vascolare momento per momento. Nel determinare il tono vascolare basale le forze meccaniche sembrano esercitare un ruolo più importante di qualsiasi fattore biochimico.
Processi patologici
(1) Ipertensione. Una deficienza di NO endotelio-derivato contribuisce sia all’ipertensione volume correlata che all’ipertensione indotta da costrizione dei vasi di resistenza.
(2) Insufficienza renale acuta e cronica. Un danno ischemico all’endotelio può avere conseguenze cliniche in quanto riduce la capacità di autoregolazione del flusso sanguigno di un organo. Questo vale per tutti gli organi e in particolare per il rene, dove l’insufficienza renale acuta appare prolungata ad opera di episodi ischemici ricorrenti associati a una pur limitata riduzione del flusso arterioso. L’endotelio danneggiato possiede capacità ridotte di generare attività di NO-sintetasi,ma incrementa la propria produzione di endotelina 1 e forse anche di altri vasocostrittori quali radicali liberi, trombossano A2 o angiotensina2. In tal modo, l’endotelio danneggiato riduce ulteriormente il flusso sanguigno e provoca ulteriore danno ischemico a livello renale, sia al sistema vascolare che al parenchima. Questo circolo vizioso può avere implicazioni per i soggetti con insufficienza renale acuta sottoposti a dialisi. Se il sistema vascolare renale è incapace di una normale autoregolazione, un calo della pressione durante la dialisi, anche modesto (fino a 80 mm Hg x 20-30’) può provocare ulteriore danno ischemico. La durata dell’insufficienza renale acuta potrebbe essere abbreviata scegliendo sistemi di dialisi che mantengono relativamente stabile la pressione ed evitano l’ischemia renale ricorrente. Sostanze vasoattive endotelio-derivate possono condizionare la crescita delle cellule mesangiali come della muscolatura liscia. Così una riduzione nell’attività dell’NO combinata con un aumento dell’attività di vasocostrittori quali le endoteline, potrebbe promuovere la patogenesi di alcune forme proliferative di glomerulonefrite.
Aterosclerosi e coronaropatie L’aterosclerosi non è solo un’ostruzione anatomica dei vasi. Il processo patologico induce modificazioni nella biochimica dell’endotelio, che a loro volta sconvolgono le attività fisiologiche del tessuto. Si ipotizza che i lipidi della placca spazzino via l’NO, causando una deficienza nella sua attività. In tal modo, quando una riduzione del flusso ematico in un’arteria coronarica aterosclerotica produce uno stato ischemico transitorio, la mancanza di attività dell’NO priva il vaso della capacità di dilatarsi e lo lascia vulnerabile allo spasmo.
Poichè l’NO è anche un importante inibitore dell’adesione piastrinica, l’allontanamento dell’NO da parte dei lipidi della placca può contribuire anche alla formazione del trombo. Sostanze capaci di indurre un rilasciamento dei vasi quando l’endotelio è intatto ( esempio l’Ach),non hanno effetto o provocano costrizione (l’Ach) quando l’endotelio è rimosso. Quindi l’endotelina 1 può contribuire all’inizio dell’ischemia o può rappresentare una risposta all’ischemia originata da spasmo delle coronarie o dalla presenza di trombi arteriosi. L’infarto coronarico può ridurre la capacità dell’endotelio di produrre NO, e nella conseguente deficienza di azione vasodilatatoria, sono sufficienti piccole variazioni della pressione e dei fattori vasocostrittori per indurre vasospasmo. Infine l’incapacità di modulare il tono vascolare da parte dell’endotelio può essere importante nell’attacco ischemico transitorio (considerato un disordine di tipo vasospastico). Se l’endotelio cerebrovascolare danneggiato non è in grado di produrre sufficiente NO, anche un incremento modesto delle catecolamine o di ormone circolante, ad esempio angiotensina, può produrre vasospasmo, che si manifesta come attacco ischemico transitorio. Nella Sepsi l’endotossina stimola la produzione di citochine , che, a loro volta, inducono l’attività NO-sintetasica. L’ NO che ne risulta può provocare un’eccessiva vasodilatazione. La sovrapproduzione di NO può provocare ipotensione associata allo shock endotossico, lo shock caldo, caratterizzato da improvvisa caduta della pressione non prodotta da una perdita di volume. In questo caso però l’uso ((come farmaco)) di inibitori della NO-sintetasi rimane problematico: l’inibizione dell’attività dell’NO blocca anche la potente azione anticoagulante di questo fattore, lasciando l’organismo esposto agli effetti procoagulanti delle stesse citochine che provocano il rilasciamento dei vasi.
Rimodellamento dell’endotelio.
In alcune circostanze, il danno all’endotelio può essere riparato e il tessuto può riprendere la sua funzione normale.
Un esempio è il danno all’endotelio polmonare causato da ipossia cronica dovuta a permanenza a elevata altitudine; il danno viene riparato e l’attività dell’NO riprende quando il soggetto scende a quote più basse. Il danno causato da aterosclerosi si corregge meno facilmente, specie se il soggetto mantiene un’alimentazione ad alto contenuto di grassi. Finché i lipidi si depositano, l’NO continua ad essere spazzato via. I vasi colpiti da aterosclerosi possono essere liberati meccanicamente mediante l’angioplastica ma il danno alle cellule endoteliali prodotto durante l’angioplastica contribuisce a ulteriori alterazioni patologiche delle arterie e probabilmente l’endotelio perde la capacità di generare attività NO-sintetasica. Secondo un recente studio (2004) l’ipertensione va interpretata come uno stato infiammatorio, infatti la proteina C-reattiva è risultata essere significativamente associata con un aumentato rischio di sviluppare ipertensione in tutti i sottogruppi analizzati. Una sistolica troppo alta segnala un sovraffaticamento del cuore e sottopone a stress i vasi, che potrebbero rompersi; una diastolica troppo alta significa che il cuore e i vasi non si rilassano bene tra un battito e l’altro.
NOTE
(1) Un sintomo che può essere indicativo di pressione alta, soprattutto se insorge da un momento all’altro è la nicturia (cioè il fatto di dover urinare durante la notte); in questo caso la pressione arteriosa rimane alta anche durante il sonno e il rene viene così sollecitato ad un superlavoro e a scaricarsi attraverso le urine.
(2) Tra le analisi del sangue spesso c’è la potassiemia, perché? Perché un eccesso di potassio (K) può essere legato ad ipertensione mentre un livello basso serve a sconsigliare l’uso di diuretici nella terapia.
venerdì 9 maggio 2014
PRESSIONE ALTA parte prima
IPERTENSIONE
parte prima
Ho già parlato in precedenza dell’ipertensione riassumendo l’elenco dei vari rimedi naturali a disposizione.
Ma per poter comprendere come funzionano le diverse terapie anti-ipertensive e scegliere un modo naturale per curarsi, è necessario avere a disposizione una dettagliata descrizione delle cause e modalità secondo cui una persona può iniziare a soffrire di ipertensione. In generale i testi che parlano di questo argomento usano termini piuttosto tecnici, di difficile comprensione per chi non ha adeguate basi di fisiologia, biochimica e farmacologia.
Mi propongo quindi l’ambizioso obiettivo di tradurre in termini facili le basi dell’argomento. Ovviamente tutto ciò richiede parecchi post per assimilare il contenuto a piccole dosi ma in modo ben circostanziato....quindi troverete di tanto in tanto sull’indice lo stesso titolo con il solito contrassegno di parte prima, seconda terza ecc ecc....potrebbe essere composto da molti capitoli: e con questo? il piacere di apprendere non contempla la fretta : -)
La pressione arteriosa é regolata da meccanismi di controllo che tendono a mantenere l’omeostasi pressoria.
(cos’è l’omeostasi? vi riporto la semplice definizione così come citata su wikipedia: “è la tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità interna delle proprietà chimico-fisiche che accomuna tutti gli organismi viventi, per i quali tale stato di equilibrio deve mantenersi nel tempo, anche al variare delle condizioni esterne, attraverso dei precisi meccanismi autoregolatori.
In molti processi biologici, l'omeostasi mantiene la concentrazione chimica di ioni e molecole, e permette alla cellula di sopravvivere.
In fisica, l'omeostasi permette di regolare altri parametri quali temperatura o energia.
Di solito questo termine viene usato in biochimica, per indicare l'equilibrio di una composizione chimica ottimale tra liquidi diversi e separati da membrane, ad esempio le membrane cellulari. Un esempio classico è la separazione tra plasma sanguigno, liquido interstiziale e liquido intracellulare”.)
I sistemi di controllo sono:
a) locali legati al consumo si ossigeno (O2) e alla presenza dei metaboliti cellulari, cioè varie sostanze che vengono “buttate fuori” dalle cellule e vengono quindi a trovarsi nel torrente circolatorio, prodotti in corso di ischemia (esempio ADP, acido lattico ) . Che cos’è l’ischemia? è una mancanza assoluta o parziale di sangue in un organo (per parziale si intende una differenza tra fornitura di sangue e la richiesta di sangue necessaria per la corretta ossigenazione del tessuto) causata da un problema fisiologico o meccanico, del sistema cardiocircolatorio.
b)nervosi costituiti dai barocettori aortici e carotidei e dal centro vasomotore. I barocettori sono dei recettori che “prendono atto” della differenza di pressione, e la denominazione “aortici e carotidei” ci indica le importanti arterie dove si trovano. Il centro vasomotore si trova nell’encefalo e precisamente nella formazione reticolare, a livello del bulbo; esso ha la funzione di regolare in maniera automatica il livello di contrazione della muscolatura liscia dei vasi e quindi per così dire dà loro il comando di restringersi o dilatarsi a seconda dell’afflusso di sangue che sta per arrivare.
Mentre i barocettori regolano rapidamente gli sbalzi pressori, ma diventano insensibili nel tempo, il centro vasomotore entra in gioco nei casi estremi e specialmente nello shock.
c)umorali: sistema noradrenalina-adrenalina (NA-A) (azione rapida); sistema renina-angiotensina (azione intermedia); vasopressina(azione lenta).
Altre componenti dell’omeostasi pressoria sono
l’atriopeptina e peptidi analoghi rilasciati dalle cellule muscolari cardiache, e modulatori del tono vasale liberati dalle cellule endoteliali quali ossido nitrico, endoteline e prostaciclina.
Questi sistemi esplicano la loro azione a diversi livelli:
-- sulla muscolatura liscia delle arteriole, determinando vasocostrizione, agiscono angiotensina,vasopressina, NA;
-- sul tono delle pareti venose con aumento del pre-carico agisce la NA;
-- sul volume plasmatico angiotensina e vasopressina;
-- tutti in vari modi sulla viscosità ematica;
-- sull’attività cardiaca con un aumento della gittata e della frequenza la NA.
Alla base della patologia vi è una ritenzione di sodio (Na) e di liquidi e/o una iper-reattività del sistema simpatico. I valori pressori ovviamente sono variabili da un soggetto ad un altro e anche nello stesso soggetto a seconda delle condizioni di sforzo, riposo, digiuno ecc.
Secondo l’OMS i valori normali sono :
per un adulto: 130-70 o 140-80
per l’anziano fino 160-90.
Valori pari a 140-90 fino a 160-104 sono già da considerare ipertensione lieve
160-105 fino a una diastolica 114 ipertensione “moderata” ! Questo ovviamente secondo la medicina allopatica. Dal mio punto di vista questo è un valore che già deve destare attenzione nel soggetto e indurlo a mettere in atto tutti i mezzi naturali per riportarlo alla normalità, se non vuole finire per instaurare una terapia farmacologica che dovrà poi fare se non per tutta la vita, per decenni!
ed infine maggiore di 160 con 115 ipertensione “severa”.
Secondo altri autori si considera ipertensione lieve quando la diastolica è minore di 100, media 100-130 e grave maggiore di 130 quindi considerano solo la diastolica; considerano anche ipertensione grave quando assieme ai valori medio-gravi si hanno insufficienza renale, insufficienza cardiaca, danni renali, alterazioni ottiche gravi.
Secondo gli attuali autori dell’OMS (2001) si considera pressione normale quella fino a 140-90; ipertensione lieve fino a 165-95; ipertensione moderata fino a 180-120 e
grave oltre tali valori.
Queste definizioni sono parecchio ingannevoli per il paziente: con il termine “moderata”, infatti, egli sarà indotto a credere che in fin dei conti la sua situazione non è così grave; se in più ha delle abitudini alimentari e comportamentali-emotive errate, non è indotto a cambiarle!
Quando è alta solo la sistolica è più predittiva di rischio
cardiovascolare cioè se la sistolica arriva a 160 e oltre mentre la diastolica non raggiunge i 95.
L’ipertensione é definita instabile quando periodi di normotensione si alternano a periodi di pressione elevata o stabile quando i valori sono costantemente al di sopra della norma, anche se possono presentare ampie oscillazioni.
Gli ipertesi presentano un aumento delle resistenze vascolari periferiche, la cui maggiore responsabile sembra essere l’ipertrofia
(ipertrofia letteralmente vuol dire iper-nutrizione; quando questo termine si applica ad una descrizione indica un aumento di volume, spessore o grandezza generale. In questo caso ci indica un aumento di spessore che però cresce verso l’interno, riducendo il diametro tubolare dell’arteria dove deve transitare il normale volume di sangue che transitava già prima di questo ispessimento )
della parete delle arterie (dette vasi di resistenza). Tale ipertrofia é responsabile della riduzione della grandezza del lume dei vasi. La stimolazione simpatica indotta dallo stress, dall’esercizio dinamico o isometrico oppure dal freddo, determina una ulteriore riduzione del calibro, già ridotto di questi vasi.
Il restringersi della canalizzazione vascolare determina un aumento generalizzato delle resistenze periferiche per cui le fluttuazioni della pressione si assestano a un livello più alto.
Nell’ipertensione essenziale la portata cardiaca é normale mentre le resistenze vascolari periferiche sono aumentate. Con il progredire della malattia la portata cardiaca si riduce, a riposo, al di sotto dei valori normali con la conseguenza che la funzione ventricolare viene compromessa per cui è ridotta la capacità del cuore di aumentare la sua portata in risposta allo stress o all’esercizio fisico. Non trattata, l’ipertensione si associa ad aterosclerosi coronarica e a cardiopatia ischemica (rischio di infarto), il che contribuisce alla incapacità del cuore di adattarsi alle accresciute richieste in caso di stress o esercizio fisico. Analoghe alterazioni si hanno a carico dei vasi cerebrali e renali. A livello renale ci sono importanti meccanismi di regolazione; quando l’irrorazione sanguigna delle cellule iuxtaglomerulari diminuisce, queste versano in circolo una maggiore quantità di renina.
Il risultato di tutto ciò sarà un’espansione plasmatica e un aumento della pressione del sistema arterioso renale.
L’ipertensione, se non viene curata, è causa di:
-- evoluzione di processi aterosclerotici;
-- lavoro cardiaco addizionale;
-- danni alle arteriole coronariche, cerebrali, renali;
-- insufficienza cardiaca congestizia;
-- infarto del miocardio;
-- insufficienza renale e uremia;
-- ictus cerebrale.
Si definisce ipertensione essenziale quella comune, quale espressione di un danno funzionale, mentre in un 10% dei casi si osserva una ipertensione secondaria , cioè scatenata da cause ben circoscritte e precisamente:
malattie organiche come ad esempio coartazione dell’aorta, nefropatie, malattie endocrine (ad esempio feocromocitoma, sindrome di Gushing), gestosi.
STOP
venerdì 2 maggio 2014
MEDITARE STANDO AFFACCIATI
Nel suo manuale filosofico destinato alla figlia, al capitolo dedicato alle varie forme di meditazione, Tumis si esprime in questi termini:
“Se fossi una scia della cometa che è Proust, o se volessi esprimermi “alla Proust”, potrei fare una carrellata delle mie finestre...o più esattamente dei miei “affacci” preferiti. E perché no? dato che mi è venuta questa improvvisa ispirazione procedo.
Ci sono sempre stati balconi e finestre dai quali mi affacciavo solo per compagnia di qualcun altro già affacciato che mi chiamava per chiacchierare: in questo caso non lo facevo per contemplare la vista che si offriva, bensì per polarizzare la mia attenzione sul soggetto già affacciato accanto a me. Non si trattava di balconi o finestre che avrei scelto per starci da sola in contemplazione.
Quelli che mi interessa esaminare ora sono piuttosto gli affacci che svolgevo e svolgo ancor oggi da sola, per guardare la vista che mi si offre senza pensare a nulla oppure pensando in modo passivo in una sorta di contemplazione. Se esiste una definizione valida per la meditazione per me è questa: osservare un panorama gradevole o un’immagine gradevole rimanendo senza pensieri o per lo meno senza pensieri che riguardino la mia vita, lasciando vagare la mente senza scopo e senza attenzione, in una sorta di trance tuttavia perfettamente sveglia.
Quando ero piccola il luogo da cui adoravo affacciarmi era un balcone situato sul lato posteriore della casa detto “la bouvette”, in quanto spesso in estate ci si cenava facendo un bouffet allestito in pochi minuti. Questo balcone dava in un cortile ed in genere non si vedevano persone ma solo il cortile ed i tetti delle case di fronte. Un panorama forse modesto ma sereno quanto bastava alle mie esigenze. Mi appagava osservare gli uccellini che si posavano sui tetti , qualche luce che si accendeva in qualche finestra in lontananza al tramonto.
Sempre nello stesso periodo, c’era la finestra della mia cameretta. Tutta la casa era disposta lungo una via in modo tale che tutte le finestre ed i balconi affacciavano da quel lato, tranne la bouvette che, formando un angolo, si affacciava anche su una via perpendicolare e il salotto che affacciava su una micro-piazzetta...ma trascorrere il proprio tempo libero in salotto a quei tempi non si usava, specialmente per i bambini senza la presenza di un adulto. I bambini, per definizione, erano portatori di disordine per cui non potevano cincischiare ovunque, bensì solo negli spazi consentiti. Eppure affacciarsi dalla finestra della sala da pranzo, o delle stanze successive, non faceva per nulla lo stesso effetto che affacciarsi dalla mia stanza. Solo da quella finestra infatti si vedeva una zona di case un po’ trasandata ed un minuscolo cortile dove era la casa del calzolaio. Poco dopo c’era un portoncino che, se passavo dalla strada, quando si apriva lasciava intravedere un giardinetto. Ecco che dalla mia camera si vedeva dall’alto tutto il giardinetto e quella vista mi piaceva moltissimo. Inoltre essendo in un secondo piano di una casa settecentesca dai soffitti molto alti, potevo vedere un bel panorama di tetti che si estendeva ben oltre le immagini in primo piano che ho appena citato. Dalla bouvette e dalla mia stanza potevo passare circa un’ora affacciata in contemplazione. Mi piaceva e basta...non mi chiedevo il perché, né la cosa esigeva una qualche spiegazione. Certe mie abitudini mi sembravano normalissime anche se gli adulti potevano rimproverarmele come perdita di tempo o, peggio, come progettazione di qualche guaio domestico.
A Porto Quadrato ho trascorso invece la mia gioventù dai 14 ai 22 anni. Anche lì il mio affaccio preferito era quello della mia stanza; in questo caso però c’è da notare che era il preferito di tutti perché il mio era il balcone più bello, più grande e da cui si vedeva un gran panorama della città e soprattutto il mare in lontananza. Così pur affacciandomi spesso da sola, mi trovavo altrettanto spesso in compagnia di qualche familiare. Di tutti gli affacci, inoltre, questo era il più scomodo per la mia salute in quanto posto al dodicesimo piano di un palazzone e dotato di una ringhiera bassa, è stato spesso motivo di inquietudine e di vertigini. Dico solo che era il miglior punto di affaccio rispetto al resto della casa perché mi permetteva di stare ben lontana dalla ringhiera, vicino al muro, seduta vicino alle piante.
Dopo la laurea avevo girato diversi luoghi d’Europa per lavoro e quindi avevo abitato da single in case in affitto o camere condivise con altre donne al di fuori del contesto familiare; ma di tutti questi luoghi non ricordo finestre o balconi particolari. A 29 anni mi sono trasferita qui dove ho messo radici, dove in seguito sei nata tu. Inizia qui la mia vera vita da persona adulta...adulta nel senso di avere una casa mia, scelta da me, secondo le mie esigenze e possibilità. Naturalmente ho scelto come altezza massima il primo piano...si perché prendendo le distanze dalla casa dei miei genitori (sede di tanti ricordi e affetti per quanto riguardava l’interno, ma anche di tante vertigini e attacchi di panico per quanto riguardava l’esterno) mi resi finalmente conto di cos’era che non andava in quella casa: l’essere al dodicesimo piano! per quei lunghi anni i miei affacci sono stati circa un quarto di quelli fatti in precedenza. Inoltre in quella fascia di età, anche un’orsa come me ha maggiori esigenze di socializzare, uscire, conoscere gente...quindi non mi accorsi della diminuzione dei miei affacci solitari. Mi resi conto della loro diminuzione solo quando riebbi l’opportunità di farli alla vecchia maniera, come chi è stato a lungo in carcere, assaporando nuovamente la libertà si dica “caspita come ero limitato nei miei spostamenti in questi anni di carcere!”. Sotto certi aspetti, paradossalmente, la vita sociale è come un carcere per il proprio spirito dal momento che ci si sente obbligati a rapportarsi con gli altri secondo certe regole di buona educazione che costringono a rinunciare a gran parte di quel tempo che si vorrebbe trascorrere in solitudine.
Ma esaminiamo dunque gli affacci del periodo da adulta, quando il partner è in equilibrio stabile, il lavoro è in equilibrio stabile e la nuova priorità è il tempo libero, il prezioso tempo libero, ed insieme ad esso il modo di abitare. La prima casa non la considero trattandosi di un’angusta camera in centro, completamente priva di affacci in quanto aveva solo una finestrella vicino al soffitto nel bagno e una finestra piccola nel soggiorno-cucina che affacciava sulle scale interne del palazzo! Una casa che fungeva esclusivamente da dormitorio e che è durata non più di un anno. La prima vera casa è stata quella di campagna, durata 8 anni. Avevo molti affacci e tutti con vista stupenda. Il mio punto preferito era questa volta quello che si vedeva dalla finestra della cucina dove si stendeva un prato verde o color paglierino o ammantato di neve secondo la stagione. Un prato in pendenza, essendo la casa su un piccolo altipiano in modo tale che il panorama si vedeva in pendenza da tutti i lati. Da quella finestra contemplavo i gatti e le loro dinamiche sociali o la caccia solitaria che facevano alle loro piccole prede. Da quella finestra alcuni cespugli di erbe selvatiche che crescevano in uno stupendo disordine e che non c’erano sul lato anteriore della casa. Un punto di affaccio in cui ci si sentiva permeati da un gran senso di connessione con la natura, con l’universo e tutto quanto (per citare Adams!). Poi c’è stata la casa di città in cui il punto di affaccio che preferivo era la finestra del bagno in cui si vedeva un piccolo pezzo del giardinetto sul retro della casa e il muro del palazzo di fronte che però mi dava poco fastidio essendo intercalato da vari alberi; infine si vedeva molto bene l’incrocio delle due grandi strade principali. Dal punto di vista ecologico un disastro per lo smog ed il rumore delle macchine o le voci confuse provenienti dal bar sottostante. Ma potendosi affacciare la sera tardi o la mattina presto aveva per me un particolare incanto. In primo piano c’erano rose ed altri fiori, poi rami di alberi e solo sullo sfondo il grigio della strada. Con gli alberi che avevo di fronte potevo parlare in un discorso silenzioso e ozioso, senza scopo, solo per il gusto della contemplazione. Nei momenti di tristezza o angoscia questo mini panorama è stato di enorme conforto ... proferivo mentalmente un lamento, un disappunto e presto “loro” mi portavano lontano da quel ragionamento e mi ritrovavo a pensare che c’erano nuove gemme su un ramo o che una gazza si era posata, e trovavo tutto questo molto più importante della mia stupida vita; mi perdevo in viaggi molto visivi e ben poco mentali, in viaggi di cose che non mi riguardavano o, per meglio dire, mi riguardavano molto più delle dinamiche riferite alla mia personalità, al piccolo io; qui era in gioco il sé oppure “quelo” o in qualsiasi modo si possa chiamare!
Ora eccomi qui,nella casa dove tu sei nata e cresciuta. Il balcone dello studio è il più privato perché vi sono addossati due alberi e un roseto per cui non si vede facilmente l’interno da fuori mentre vi si può godere il fresco o il sole senza essere visti. E’ quello più vissuto per la grandezza, la comodità e la presenza delle piante. Ma lo considero come una stanza in più, non come un affaccio; infatti affacciarsi da li porta a vedere la strada in piena curva, circondata da case più alte della mia e senza particolari attrattive. Dal balcone del soggiorno si vede ancora una strada in tutta la sua lunghezza fino all’orizzonte. Il balcone della cucina è molto carino ma non mi ispira agli affacci solitari. Ed ecco che fin dal primo giorno ho potuto individuare la finestra del bagno come punto preferito. Si vedono scorci del giardinetto che attornia la casa, molti alberi e la casa di fronte con una magnifica grande scala esterna disposta a spirale. Mi sembra di avere di fronte la casa di marzapane delle fiabe! Ma a parte questo, ciò che conta è il magnetismo particolarmente benefico che si percepisce solo da quel punto! Non è stata una scelta calcolata, è stata piuttosto una percezione inequivocabile.”
Appare evidente come questa narrazione non riguardi fatti realmente accaduti e abitazioni ben precise realmente esistenti. Il mio augurio è che possa servire a facilitare il concetto che voglio esprimere invitandovi a meditare con questa modalità: affacciandovi da un punto preferito di casa vostra e lasciando vagare i pensieri come un sottofondo piuttosto sfocato, mentre focalizzate la vostra attenzione su ciò che vedete e sentite nel qui ed ora.
STOP
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Informazioni personali

- Marina Salomone
- Mi occupo di terapie olistiche dal 1983. Hobby principale il disegno: sono su Flickr sotto il nome di Marina Salomone
per chi fosse interessato a trattare questi argomenti in maniera più appofondita c' è sempre il mio sito web ufficiale: www.GurudiTamara.com